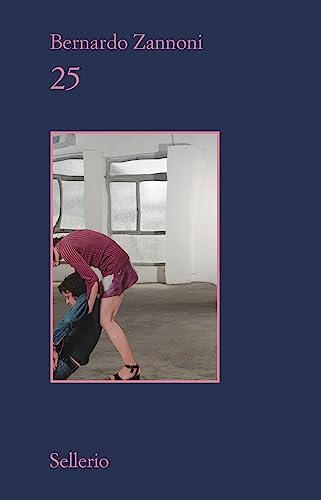di Carmen Rampino
Ci sono immagini che prendono il loro alito di vita dalle parole.
Ci sono parole che si animano grazie alle immagini.
Ci sono immagini che non solo rendono la parola più incisiva, ma la accarezzano dolcemente, diventando indispensabili per essa, affinché si possano esprimere concetti che, in altri modi, difficilmente potrebbero esprimersi.
Ci sono molte parole mute e paralizzate se non hanno il supporto delle immagini.
Il miracolo che nasce quando questi due linguaggi si incontrano è storia, precisamente una storia, quella del graphic novel. Definito da Stefano Calabrese ed Elena Zagaglia come «uno dei fenomeni più straordinari della letteratura contemporanea» (Calabrese–Zagaglia 2017, p. 7), l’emergere del graphic novel ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. Per avvicinarci sempre più all’interno del laboratorio artistico di quest’arte senza tempo, abbiamo approfittato della recente pubblicazione (novembre 2023) per La Ruota Edizioni di Un bracciale di stelle (Mentana-Guida 2023), graphic novel scritto da Umberto Mentana e disegnato da Giuseppe Guida, per analizzare più da vicino i ferri di un mestiere che richiede una fatica e una perizia da orafo o miniaturista. In questo caso si è trattato di un lavoro durato due anni. Come ci ha spiegato il disegnatore Giuseppe Guida, l’opera è una particolare trasposizione a fumetti di un libro del 2019, Io mi dono,della giornalista foggiana Michela Magnifico, la quale collabora con l’associazione AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma). Infatti, il fumetto pone al centro le storie vere di malati e volontari dell’associazione, narrate all’interno della cornice finzionale che vede la giovane giornalista Greta imbattersi nell’associazione AIL di Foggia, venendone travolta e cambiata per sempre attraverso le storie di dolore, forza, lotta e resistenza che verrà a conoscere. Se Io mi dono era un libro dossier contenente le storie vere dell’associazione AIL di Foggia, la trasposizione a fumetti, con un pizzico di fantasia, riesce forse in maniera ancora più calda e penetrante ad arrivare al cuore dei lettori attraverso i colori, le metafore disegnate e le immagini che stringono la gola e si attaccano alla pelle del lettore, come quella della morte, non così perfida come ci si aspetterebbe, ma una cara morte, quasi eco buzzatiano del Poema a fumetti del ’69.
L’AIL sezione di Foggia è la prima in Italia ad aver deciso di affidare al fumetto la possibilità di narrare la sua storia, proprio con il preciso scopo di arrivare a quante più persone possibili. Tale scelta è estremamente eloquente dal punto di vista del medium e del momento florido che sta vivendo. Il fumetto si configura sempre più come luogo in grado di sensibilizzare, divulgare senza essere didascalico, un vero e proprio strumento politico trasversale. In questo caso al centro ci sono i temi del volontariato, dell’altruismo, dell’associazionismo, temi che hanno un’immediata ricaduta sociale. Come ci conferma Guida, negli ultimi 10 anni il fumetto è entrato nelle scuole, in cui vengono abitualmente adottati testi sull’antimafia o il razzismo a fumetti. Da strumento considerato nocivo per le giovani generazioni, si è dunque arrivati alla convinzione che non solo con tale linguaggio si possa trattare qualunque argomento, ma anche in maniera più efficace, incisiva e toccante. Per approfondire meglio i segreti di quest’arte quasi ossimorica, quella che può fare critica sociale, però toccando le corde più profonde della nostra emotività, quella che divulga in maniera gentile, ma allo stesso tempo ribelle e disubbidiente, e per approfondire la sfida della riscrittura trasformando un libro di non fiction in un libro di fiction, abbiamo incontrato direttamente i due creatori e conversato con loro sul progetto realizzato e sulle sorti del fumetto.
Ciao, potete raccontarmi come è nato questo progetto?
G.: Il progetto nasce dall’associazione AIL di Foggia. Io sono stato contattato da Michela Magnifico, giornalista di TeleFoggia, attiva collaboratrice dell’associazione e autrice di Io mi dono del 2019, da cui è tratto il fumetto. Esattamente, l’idea di produrre un fumetto è nata ad un primo evento AIL al Teatro Giordano, in cui io disegnavo dal vivo. Ho conosciuto lì tutta l’AIL e, in particolar modo, Michela, che mi ha lanciato la proposta. Quindi, conoscendo Umberto, e intuendo poi anche la struttura che poteva e doveva avere la storia, abbiamo iniziato a collaborare.
Se si tratta di una trasposizione a fumetti del libro di Michela Magnifico Io mi dono (2019), perché realizzare un fumetto da un libro già esistente?
G.: Perché loro volevano dare continuità al messaggio dell’associazione arrivando ai giovani. Il mezzo più efficace qual è? La lettura di un fumetto.
Quale tecnica è stata utilizzata per la parte grafica?
G.: In questo lavoro io ho riposto il mio stile, il mio tratto, che non è realistico, ma collocabile tra il cartoon e il grottesco. Conoscendoci, Umberto mi ha lasciato la libertà di potermi muovere e insieme abbiamo cercato di dare continuità allo stile, alla dinamica e soprattutto alla colorazione, scelta particolare perché abbiamo optato per questo turchese/celeste, un colore di speranza soprattutto per chi ha sofferto, in contrasto con il tradizionale bianco e nero, proprio per far trasparire anche un senso di leggerezza. Questa costante attenzione per i dettagli spiega anche perché ci siano voluti più anni per portare a termine il progetto.
Effettivamente si vede che ogni piccolissimo elemento è frutto di una scelta mai casuale. Ma è stato fatto in digitale?
G.: Sì, io lavoro in digitale da un anno e mezzo più o meno.
E invece a livello linguistico che lavoro è stato fatto? E come, in un secondo momento, la sceneggiatura e la parte grafica sono state messe insieme? Come è stato mescolare parole e immagini affinché diventassero una cosa sola?
U: Tutto il discorso è partito da un libro che non era un romanzo o un libro di finzione ma un libro reportage, un libro dossier di testimonianze in cui sono riportate le varie vicissitudini sia dei malati che dei volontari, senza un vero e proprio filo narrativo. Io poi ho operato un lavoro di traduzione attraverso le immagini dando una continuità narrativa. Quindi il libro di raccolta di testimonianze della giornalista Michela Magnifico, intitolato Io mi dono, adesso ha dato vita ad un’altra cosa, che ha un’altra natura. Da lì io ho cercato di selezionare le testimonianze, quelle un po’ più “filmabili”, cioè quelle che potevano essere benissimo rese per immagini, e da quelle poi ho cercato una continuità finzionale attraverso la creazione di Greta, personaggio di mia invenzione. Greta è una giornalista che arriva un bel giorno nell’AIL di Foggia e scopre una realtà totalmente nuova, fatta di persone che lottano, ma anche di volontari che praticamente si applicano anima e corpo per trovare una soluzione e alleggerire vite. Accanto a questo, nel libro compaiono tante altre situazioni anche visivamente interessanti, come la malattia che si personifica o la morte, che pure ha una certa sensibilità per gli affari dei vivi e non è connotata in maniera negativa, anzi vi è tutta una parte che ho chiamato proprio I doni della morte, citando, in un certo senso, Harry Potter. Poi si è lavorato sulle singole immagini e sulle singole inquadrature: in fondo lo sceneggiatore funziona anche un po’ da regista nel fumetto, perché a differenza del regista cinematografico e dello sceneggiatore cinematografico che sono figure staccate, nel fumetto c’è un connubio delle due.
Quindi le redini ce le avevi tu di fatto?
U.: Sì, della parte narrativa sì. Io lavoro con un approccio molto visivo anche nella creazione dei testi. Infatti non scrivo solo la sceneggiatura con le battute, ma lavoro sulle immagini, sugli storyboard. Quindi lavoro già disegnando qualcosina abbozzato (perché sono totalmente incapace di disegnare) proprio per vedere l’impatto della tavola, il ritmo, il montaggio. Da lì faccio tutto un fumetto muto. Questo è il mio modo di lavorare, ma ci sono altri sceneggiatori che sono molto narrativi perché provengono dal romanzo. Io, provenendo dalla sceneggiatura cinematografica, dal cinema e da produzioni video, ho un approccio visivo, ma non c’è un modo giusto o sbagliato di lavorare. Però di base si parte da questo libro che non era narrativo e si è cercato di dare una continuità. Infatti si presenta come se fosse diviso un po’ in capitoli perché ci sono tante storie che si intrecciano e poi si riuniscono in un cerchio, il bracciale di stelle appunto.
E poi questo storyboard provvisorio viene dato a Giuseppe?
U: Sì, che lo lavora a seconda del suo stile, mantenendo un po’ le mie indicazioni, ma anche inserendovi del suo.
E in questa fase tu hai già scritto i testi definitivi?
U.: In questa fase dipende anche dalle richieste della casa editrice, perché dobbiamo sempre tener conto della sua revisione. Se chiedono già di inviare la sceneggiatura con i testi sì, però di base a Giuseppe potevo anche inviare a scaglioni degli storyboard provvisori.
Forse è anche più difficile svolgendo in due il lavoro?
U.: Sono lavori diversi secondo me, perché il disegnatore ha un suo approccio, che è diverso da quello del narratore. Poi, ovviamente, ci sono anche, pensiamo a Zerocalcare o Gipi, disegnatori che sono pure autori, ma loro hanno un approccio da narratori, nel senso che sì, sono anche bravissimi disegnatori, ma il loro obiettivo è soprattutto narrare la storia. Secondo me chi è realmente narratore si deve veicolare verso la parte narrativa che è anche una parte per immagini, perché lo sceneggiatore a fumetti lavora di sintesi, cioè una immagine deve già narrare qualcosa, non ci deve essere necessariamente il testo che deve spiegare. Affiancando semplicemente una immagine all’altra ci deve essere già una natura di progresso della storia.
Oggi non solo il fumetto ha molta visibilità, ma sempre più sembra quasi l’unico medium in grado di rimanere un cantuccio di sensibilità, impegno, quasi di “militanza”. Quanto è importante il fumetto per diffondere messaggi delicati come questo? La sua ibrida e doppia natura in qualche modo riesce ad essere più incisiva? Perché si sceglie proprio questo medium?
U.: Secondo me è cambiato il modo di recepire proprio la cultura. Siamo nella civiltà delle immagini, del successo della serialità televisiva, che ha un potenziale meno registico ma più da scrittori. Siamo continuamente circondati da immagini in movimento, da disegni, da foto, quindi questo è il modo non solo per avvicinare le nuove generazioni, ma in generale fa più presa perché la cultura del tempo è cambiata. Il cosiddetto Zeitgeist è cambiato perché siamo circondati da immagini.
Se non ho capito male, a voi è stato chiesto di fare questo progetto. Da ciò ci si poteva aspettare che la questione potesse essere affrontata come una sorta di sovrastruttura imposta dall’esterno quasi in modo forzato e soprattutto didascalico, eppure sembra che il tema lo abbiate fatto vostro, diventando a tutti gli effetti un bisogno personale. Dunque, quale rapporto, prima di tutto a livello umano, e poi artistico, vi lega alla causa?
U: Alla fine commissionato o non commissionato, uno è libero sempre di accettare o meno un progetto. Siamo autori, abbiamo una certa sensibilità per alcuni temi e per altri no. Questo progetto, parlo per me personalmente, era interessante, anche al di là del tema trattato, per la sfida di traduzione, traduzione da un libro che non era narrativo a una trasposizione in immagini. Era una nuova sfida che non avevo mai affrontato. Solitamente io scrivo su soggetti totalmente originali, quindi di mia invenzione, in questo caso invece si tratta di un soggetto solo parzialmente di mia invenzione, perché è tutto un gioco di puzzle, di incastri. Però mi piaceva l’idea di fare un riadattamento a fumetti.
G.: Se il progetto è nato è sicuramente perché ci ha emozionati un po’ tutti profondamente. Questo è il mio primo progetto che affronta una tematica così delicata, soprattutto poi nel come è stata interpretata nei disegni: pensiamo alla rappresentazione della morte. Spesso si leggono fumetti fantasy o horror, in cui il tema viene trattato con un’altra metodologia tecnica. In questo caso si è cercata una modalità tale che anche un bambino può avere un approccio emozionante, simpatico e non duro o forte. Aggiungo che il libro sta andando in tournée nelle scuole. Crediamo che questo linguaggio, questo modo di far leggere un fumetto sia un intervento importante e interessante. Dunque siamo orgogliosi di aver potuto realizzare il progetto.
Un’opera del genere presuppone una sorta di asimmetria tra chi deve dare voce all’altro e l’altro che, per quanto interpellato e coinvolto, non parla direttamente. Nel fare questo lavoro avete sentito il peso di una responsabilità? Cioè in un momento in cui tende a prevalere molto l’io nelle narrazioni contemporanee, non solo quelle a fumetti, voi avete scelto di scrivere una storia di tutt’altro tipo: come si fa a dare voce ad altri? In questo caso si tratta, tra l’altro, anche di persone viventi.
U.: È un lavoro complesso. Infatti è strano affrontare dal vivo i personaggi che erano su carta. Oggi, in conferenza stampa, è stata la seconda volta che ho incontrato il dottor Ferrandina (ematologo e presidente AIL Foggia divenuto uno dei protagonisti del fumetto N.d.R.) di persona, a parte una presentazione all’interno di una manifestazione dell’AIL di un paio di anni fa, quando il progetto è partito, ed è particolare vedere queste persone che sono persone reali. È una strana sensazione assistere a questo fenomeno. Ricorda un po’ una sensazione di cui, come ultimamente leggevo, ha parlato Paola Barbato, l’autrice di Dylan Dog e di romanzi thriller. Lei raccontava che adesso è partita la lavorazione per un film, Mani nude,tratto da un suo romanzo e, incontrando gli attori, diceva di provare questa strana emozione nel vederle vivere quelle creature che erano su carta. Nel nostro caso è ancora ulteriore il passaggio, perché sono ritratti di vita reali e non sono personaggi partoriti solo su carta. La responsabilità ovviamente è tanta perché si tratta anche di temi molto delicati. Per noi è stata un’esperienza totalmente immersiva da un punto di vista emotivo, perché si racconta la lotta con la malattia, l’impegno per rendere a volte meno sofferente e a volte sconfiggere questa terribile malattia. Quindi ci siamo sentiti estremamente responsabili nel dare voce a persone che hanno donato questo impegno per riuscire a diffondere le loro voci, perché comunque stiamo parlando delle loro vite, non sto inventando nulla, cioè solo parzialmente.
Negli ultimi anni sempre più persone si interrogano sul fumetto, sul suo successo ma anche sulla sua precarietà, voi che previsioni vi sentite di fare su questa nona arte?
U.: Ahia, altra responsabilità. Sicuramente il fumetto vive di buona salute, perché, sempre ritornando al discorso legato ad una civiltà totalmente dedita alle immagini – immagini in movimento, immagini disegnate e così via – io credo che, anche grazie alle potenzialità del web, il medium possa rinnovarsi e trasformarsi, ma non scomparire. Pensiamo ai web comics che tutti conosciamo: in quel caso è cambiata la loro fruizione, perché anziché sfogliare le pagine, le scrolliamo, si potrebbe dire che è un po’ un ritorno ai papiri, andando nella verticalità e non seguendo il punto di vista orizzontale del voltapagine. Dunque le possibilità sono infinite, ricordiamoci che si tratta di un medium nato alla fine dell’Ottocento, quasi in corrispondenza con il cinema, e che i primi fumetti apparvero sui quotidiani. Io credo, dunque, solo che il fumetto possa prendere nuove strade, come ha fatto anche il cinema e la televisione.
TESI CITATI.
Stefano Calabrese – Elisabetta Zagaglia, 2017, Che cos’è il graphic novel, Roma, Carocci editore.
Michela Magnifico, 2019, Io mi dono, Molfetta, la meridiana.
Umberto Mentana – Giuseppe Guida, 2023, Un bracciale di stelle, Roma, La Ruota Edizioni.