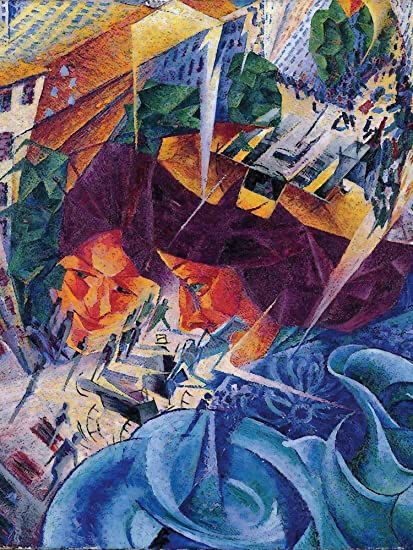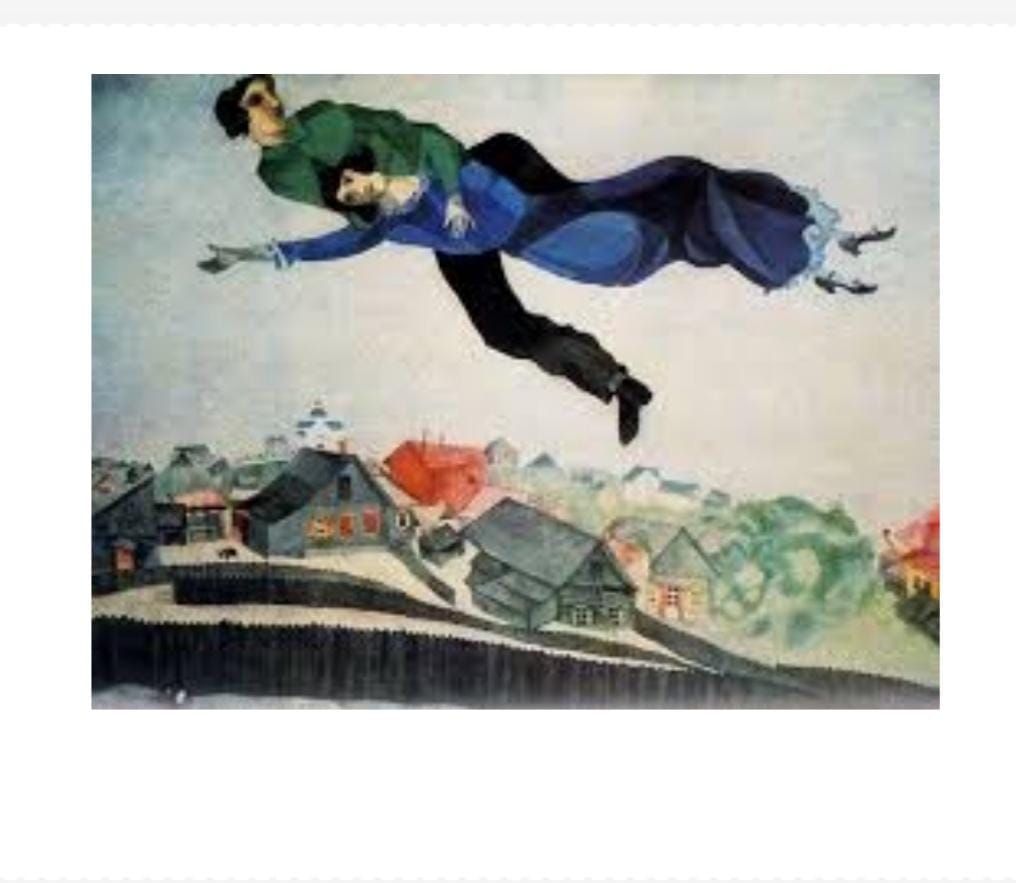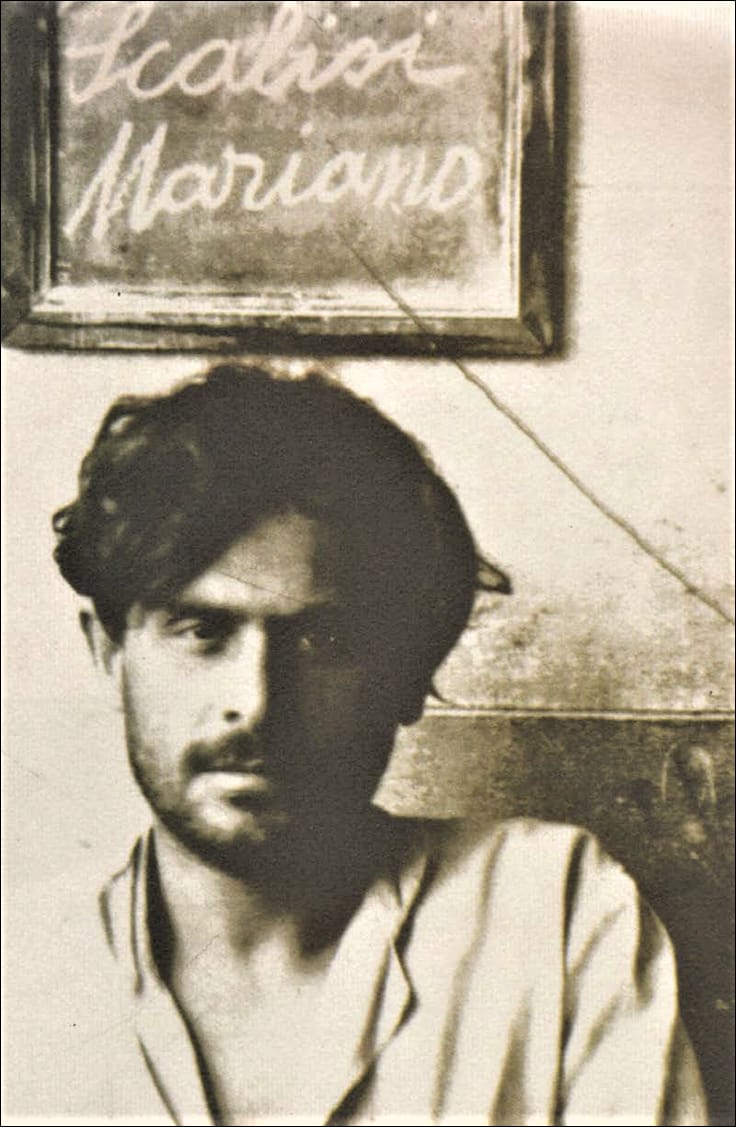di Pierluigi Mantova
C’è un passaggio necessario nel famoso Viaggio dell’eroe – che oltre ad essere un libro è innanzitutto un paradigma narrativo – in cui l’eroe, dopo aver superato prove e ostacoli nel mondo straordinario, fa ritorno a casa (il mondo ordinario da cui era partito) con l’elisir, che può essere materiale (un oggetto fisico che l’eroe ha recuperato in una missione) o una consapevolezza che ha acquisito e che porta nel suo contesto originario, di modo che ci possa essere uno scioglimento (o risoluzione) della domanda drammaturgica iniziale che ha spinto l’eroe a partire. Questa tappa del ritorno a casa è visibile non solo nelle storie che raccontiamo, ma anche in chi le racconta. Senza scomodare i miti del mondo antico, da cui il paradigma trae ispirazione, si può parlare di autori in cui “ritornare” diventa un passaggio necessario per la loro penna.
Ognuno di noi, in qualche modo, è chiamato all’avventura – anche se non tutti varcano la soglia o fanno ritorno a casa. Sta di fatto che leggendo i libri di Édouard Louis si nota proprio questo: ritornare al contesto di partenza, ma con uno sguardo critico, che non ha l’obiettivo di processare qualcuno, ma anzi si propone di comprendere il passato operando un distacco critico, ponendo l’oggetto al centro della scrittura e sviscerandone ogni aspetto.
Leggere Édouard Louis significa avere a che fare con il grido di un millenial attivista che si fa strada nel mondo con un’autobiografia camminante, non seppellita in un antico cimitero o dimenticata sulla pagina di un polveroso manuale di letteratura – ma dinamica, effervescente, viva. L’autore nasce come Eddy Bellegueule nell’Alta Francia, il 30 ottobre 1992, in un misero paesino post-industriale che conta poco più di mille anime. La famiglia appartiene alla classe operaia, il padre lavora in fabbrica e la madre è chiusa in casa ad accudire i figli. Louis racconta l’infanzia amara e problematica nel suo primo romanzo Farla finita con Eddy Bellegueule, pubblicato nel 2014 e diventato in poco tempo un caso editoriale. Il sociologo Pierre Bordieu – che l’autore ha a lungo studiato – sostiene che le classi popolari vengono private di tutto: cultura, possibilità di viaggiare, accesso alle città, denaro, istruzione. L’unica cosa che gli resta è il corpo. Lo stesso Louis, parlando del suo libro in un’intervista a l’Internazionale,cita il sociologo francese: «Bordieu sottolineava che non dobbiamo stupirci se in gran parte delle classi popolari emerga un’ideologia del corpo, della forza, della mascolinità, un’ideologia che inevitabilmente produce una violenza sulle donne, sulle persone omosessuali, trans e su tutti i “dissidenti” dell’ordine sessuale. In questo senso potremmo dire che la violenza maschilista è legata alle privazioni economiche. In quel contesto io ero un ragazzo gay, effeminato». Un pensiero che sembra incastrarsi con ciò che esprimeva anche Pier Paolo Pasolini: «Ciò che resta originario nell’operaio è ciò che non è verbale: per esempio la sua fisicità, la sua voce, il suo corpo. Il corpo: ecco una terra non ancora colonizzata dal potere». Quel Pasolini da cui Louis prende le distanze, dal momento che l’autore friulano mistificava la classe proletaria, cosa che invece lo scrittore francese rifiuta di fare abbandonando l’idea che chi è povero è automaticamente puro.
L’approccio che Louis usa non è quasi mai di commiserazione o di amara nostalgia, al contrario la sua penna ha uno stile quasi giornalistico. L’autore rilegge gli eventi del suo passato non con una lente inquisitoria, ma in una chiave psicoanalitica. Tra le pagine dei suoi libri non pendono taglie sulla testa di un criminale né si va alla ricerca di un colpevole – non esiste condanna o assoluzione – ma si racconta l’individuo in relazione al suo contesto e ne si fa un’autopsia del corpo.
Eddy Bellegueule desidera adeguare il suo corpo a un contesto machista, omofobo, razzista e sessista, ci prova corteggiando una ragazza, negando i suoi impulsi sessuali e avviando un percorso di adattamento all’ambiente sociale che si concluderà con un fallimento, e la conseguente partenza verso la metropoli: «Farla finita con Eddy Bellegueule racconta l’incontro impossibile tra il mio corpo e il mio ambiente sociale» – precisa Louis – «Nel libro uso l’impossibilità per il mio corpo di esistere in quell’ambiente come uno strumento per analizzare e comprendere il contesto sociale». Per la classe operaia il valore più importante è la mascolinità, la virilità, con una connotazione fortemente tossica. L’uomo non è un essere verbale, ma animale. È prigioniero dell’idea del fare: perché fare significa produrre, e produrre vuol dire esistere. Il maschio esibisce le riviste pornografiche sul tavolo di casa come un trofeo, ha la bocca farcita di parolacce, si misura con i suoi simili con la violenza fisica, è inserito in una gerarchia polarizzata nella dicotomia “forte – debole” dove l’interazione si esprime per mezzo del corpo, usato come strumento di affermazione e riproduzione. Eddy è il primo della sua famiglia a concludere la scuola e a trasferirsi a Parigi, dove prosegue gli studi e decide di cambiare definitivamente il suo nome.
Édouard Louis rifiuta la finzione perché non corrisponde alla sua idea di letteratura: «Mi sono sempre detto che il gesto principale della letteratura dovrebbe nascere dalla vergogna, dovrebbe essere cosa scriviamo partendo dalla vergogna» – continua Louis – «Davanti alla quantità globale di violenza nel mondo non possiamo continuare a scrivere le piccole storie della borghesia urbana, non possiamo farlo senza provare vergogna». L’atto letterario nasce da un evento che provoca vergogna, e la vergogna tocca la sfera dell’intimità individuale. Quella vergogna che a volte divora e altre consuma, ma che scaturisce da un giudizio esterno sulla propria persona, da quello spazio sociale in cui opera invisibile la politica. Ecco perché in Louis l’atto letterario diventa, per necessità, azione politica.
Non molti giorni fa uno studente di 22 anni, mentre tornava a casa di notte, è stato rapinato e stuprato a Roma, nel quartiere San Lorenzo. Quando ho riferito la notizia a un amico, subito mi ha detto: «Non me ne parlare». Ho pensato a quanto la violenza possa ferire anche solo a livello immaginativo, ma penso si sia infastidito perché in questo caso si trattasse di un maschio – proprio come me e lui e tantissimi altri. I media non riportano spesso notizie di violenza sugli uomini, anzi, la narrazione “mostrifica” l’uomo tratteggiandone sempre di più una figura bestiale, dominata da una rabbia cieca che, una volta esplosa, uccide. Non ci si interroga sui perché di quelle azioni brutali, si comunica la notizia e basta, senza fornire un contesto e ciò spiana la realtà fino a farla diventare bidimensionale. Cosa ancor più inquietante e pericolosa è assegnare un colore o un genere alla violenza: sentiamo spesso parlare di “violenza di genere” o “violenza sulle donne” come se l’atto violento avesse delle sottocategorie di cui si può parlare, perdendo però di vista il punto: cioè che qualsiasi tipo di violenza è già di per sé imputabile, a prescindere dal destinatario di tale azione. In Louis questo pericolo non esiste, perché lo scrittore non racconta solo l’accaduto, ma analizza il contesto di provenienza della persona che ha consumato lo stupro mettendo l’accento su quanto il carnefice, prima di diventare tale, sia stato egli stesso vittima di un altro tipo di violenza sia sociale che politica. L’autore ricostruisce i fatti non solo dai suoi ricordi, ma anche dal punto di vista della sorella che distorce gli eventi sminuendo quasi l’accaduto, a volte minimizzando a volte sorvolando sui dettagli.
Il secondo romanzo Storia della violenza, pubblicato nel 2016,mescola il verbale scritto di una denuncia a un diario segreto, in cui si percepisce la fatica di dire a voce alta una scomoda verità. Édouard Louis attraversa Parigi a piedi, di ritorno da una serata tra amici, in una città deserta e sazia, quasi spettrale durante le festività natalizie. Durante il cammino incontra un immigrato algerino, Reda, e i due trascorrono la notte insieme. Lo straniero racconta delle umiliazioni subite in prima persona, la storia di suo padre e la sfortuna di essere cresciuto “dalla parte sbagliata del Mediterraneo”. In un attimo, la camera di Louis si trasforma in una “stanza della tortura”: Reda tira fuori una pistola, prima prova a rubargli il computer, poi lo lega e gli usa violenza. Il racconto è un mosaico che si compone pagina dopo pagina, comincia con lo scrittore che ripulisce la stanza dopo quell’orribile notte e si conclude con il sopralluogo della polizia sulla “scena del crimine” dopo la denuncia dello scrittore. Nel mezzo la penna di Louis prova a “umanizzare” la violenza subita, senza toni melensi o vittimistici, anzi la calma e la lucidità con cui scrive affascinano il lettore che, proprio come lui, guarda l’accaduto come fuori dall’inquadratura. Proprio questa oscillazione tra trauma personale ed esperienza collettiva è ciò che ha catturato l’attenzione di Thomas Ostermeier, 53 anni, il più conosciuto e applaudito regista del teatro tedesco odierno che ha trasformato il romanzo in una drammaturgia firmata da lui stesso con Florian Borchmeyer e lo stesso scrittore francese. «Il lavoro di Louis mi interessa» – spiega Ostermeier – «perché dà voce agli emarginati, a chi vive in povertà, a chi vive con disagio in questa Europa che vuole essere il continente dei pochi felici. Louis parla di classi sociali, di ricchi e dominanti e di poveri marginalizzati. L’ultimo a fare qualcosa del genere è stato probabilmente Bertolt Brecht. Io la considero una linea importante del mio lavoro».
Lo spettacolo è stato messa in scena al teatro Schaubühne di Berlino nel 2018, per poi approdare per la prima volta in Italia al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Seguito nel 2020 da un altro spettacolo tratto dall’opera dello scrittore francese Chi ha ucciso mio padre portato in scena da Daria Deflorian e Antonio Tagliarini in un “dialogo per voce sola”, interpretato da Francesco Alberici. Il terzo romanzo dell’autore, pubblicato nel 2018, è una “lettera al padre”, scritta a cento anni dall’originale di Franz Kafka, dedicata alla violenza scaturita dal fallimento della generazione operaia post ‘68, condannata a morte dal proprio degrado sociale. In questo pamphlet autobiografico, Louis si mette alla ricerca degli assassini del padre con tanto di nomi e cognomi: Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, in cui trova spazio la feroce invettiva verso un potere politico che l’autore considera l’unico colpevole della sorte del padre, abbandonato in una casa di campagna come un giocattolo difettoso.
Quello stesso padre che era ossessionato dalla virilità e consapevole di essere sottomesso da una classe politica che non ha scelto, emarginato da una società che non lo vuole, sconfitto proprio come le persone che più odia e a cui ha paura di somigliare: donne, stranieri, omosessuali. Un uomo ferito da una moglie che l’ha lasciato e da un’industria che gli ha spezzato la schiena, ma che comunque è pronto a mostrarsi vulnerabile davanti al ritorno di quel “figliol prodigo” che bussa alla porta, ormai cresciuto e consapevole di trovarsi di fronte a una sola e povera vittima del sistema: «Non ho mai visto le famiglie che hanno tutto andare a vedere il mare per festeggiare una decisione politica, perché la politica a loro non cambia quasi nulla.» – scrive Louis nel libro – «Me ne sono accorto quando sono andato a vivere a Parigi, lontano da te: i dominanti possono lamentarsi di un governo di sinistra, possono lamentarsi di un governo di destra, ma un governo non gli causa mai problemi di digestione, un governo non gli spacca la schiena, un governo non li spinge mai verso il mare. La politica non cambia la loro vita, o così poco. Anche questo è strano, fanno la politica e la politica non ha quasi nessun effetto sulla loro vita. Per i dominanti la politica è nella maggior parte dei casi una questione estetica: un modo di pensarsi, un modo di vedere il mondo, di costruire la propria persona. Per noi, era questione di vita o di morte».Chi ha ucciso mio padre di Édouard Louis riporta alla mente un altro libro, uscito qualche anno prima, Ritorno a Reims di Didier Eribon che fa eco a una drammaturgia (sempre francese) dal nome Juste la fin du monde di Jean-Luc Lagarce di cui è stato fatto un adattamento cinematografico dal regista canadese Xavier Dolan, un giovane cineasta molto vicino, per stile e tematiche, allo stesso Louis. Gli autori si sfidano, si accarezzano, si somigliano nel percorrere la strada di casa, la stessa che hanno battuto mentre andavano via. Proprio come l’eroe che, dopo aver concluso il suo viaggio, fa ritorno a casa perché ha bisogno di essere visto, accettato, riconosciuto attraverso la sua cicatrice.