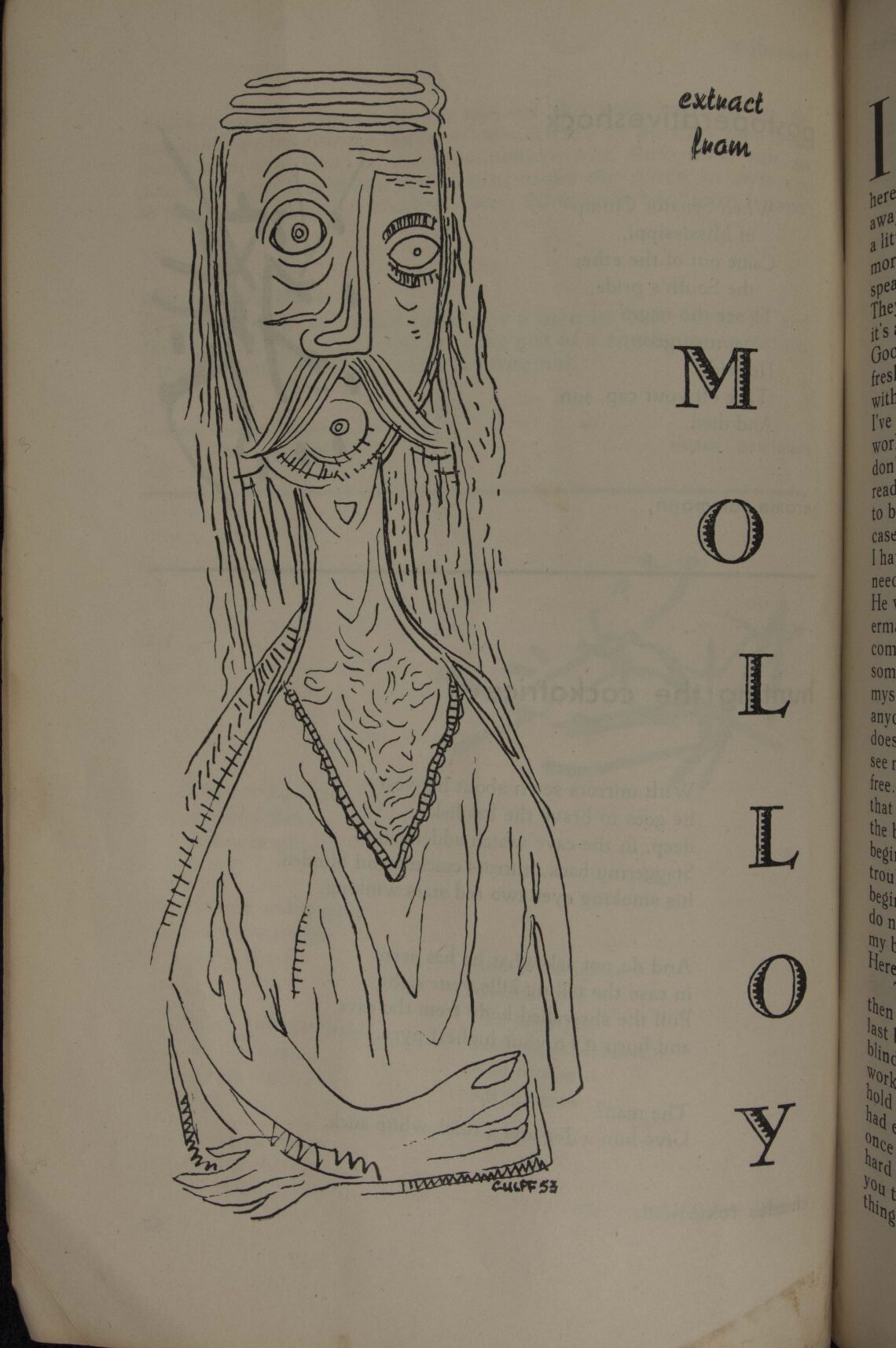di Demetrio Paolin
[le pagine citate nel testo si riferiscono al meridiano Mondadori, Samuel Beckett Romanzi, teatro e televisione a cura di G. Frasca]
1. pp.497-557
Incipit/Preambolo. L’incipit di un testo è sempre problematico, l’attacco con cui lo scrittore decide di portarci dentro una storia produce il tono del racconto. L’attacco di Molloy è rapido, pare semplice, per nulla ambiguo, in una parola potremmo definirlo chiaro. “Sono nella camera di mia madre” (p.497). Prima di andare avanti con la nostra ricognizione dobbiamo ricordarci il monito di Adorno, contenuto nel saggio Schizzo per l’interpretazione dell’Innominabile, che a parer mio può essere perfettamente applicato anche a Molloy e alla scrittura e all’opera di Beckett tout court. Adorno scrive che è necessario: “leggere ogni frase dell’inizio alla fine”. Fedeli a questa ipotesi proviamo a leggere questa frase dall’inizio alla fine, la prima cosa anzi che dovremmo comprendere è cosa significhi leggere, quale tipo di realtà oggi si schiuda nella decifrazione, che pare involontaria, mentre è appunto uno sforzo continuo e macchinoso del nostro cervello. Beckett ci costringe a leggere, ci costringe a muoverci all’interno di frasi brevi, semplici sintatticamente, ma nello stesso tempo di profonda ambiguità. Ad esempio non possiamo dimenticare che Molloy è in realtà un romanzo doppio e questo già modifica in parte la nostra concezione del testo, è testo scritto primariamente in francese e successivamente in inglese; non entriamo ancora nel merito di questa scelta, ma ci avviamo a constatare che il passaggio da una lingua all’altra, da una sonorità all’altra, è anche il passaggio da un significato all’altro. Nell’edizione francese leggiamo: “Je suis dans la chambre de ma mère”; nell’edizione inglese “I am in my mothers’s room”. Che ci sia una tensione tra chambre e room mi pare evidente e ne è una spia la diversità delle traduzioni italiane: Frasca scrivere “camera” e Tagliaferri ad esempio “stanza”. La modificazione della parola nelle due lingue mi porta a fare un ragionamento: il termine room ha un significato più ampio di chambre, ad esempio potremmo anche leggerlo come “spazio”, posto, luogo. È chiaro che l’incipit di Molloy è una situazione, l’ubicazione esatta da cui si parla, da uno spazio verrebbe da dire che è lo spazio della madre, che quindi non diventa come vedremo soltanto la meta verso cui dirigersi, Molloy è un romanzo almeno nella prima parte di movimenti, di movimenti spirali, di andirivieni, di pause, incontri stravaganti e ri-partenze, ma appunto diventa da subito lo spazio che l’io narrante ha in qualche modo occupato: si potrebbe dire che con questo incipit l’io narrante testimoni il suo essere al posto di sua madre, come se ci fosse stata una sostituzione, lui ne fa le veci, sua madre è morte e l’io narrante l’ha sostituito: “Come che sia ci sto io nella sua camera. Dormo nel suo letto. La faccio nel suo vaso. Ho preso il suo posto” (p.497). Come vediamo la sostituzione, l’ “in vece di”, è annunciata poche righe più sotto ma è contenuta completamente nelle prime righe e nella differente resa di room e chambre. Queste prime pagine mi hanno ricordato in maniera certi passaggi di Ignazio de Loyola e dei suoi Esercizi Spirituali. Una delle caratteristiche importanti dei preamboli di alcuni esercizi sta nell’immaginare un luogo, o meglio di visualizzare non un luogo qualsiasi ma un preciso spazio, l’inferno, il Golgota, il paradiso terrestre. Prendo l’esercizio della quarta settimana, il 2° preambolo: “composizione visiva del luogo, che qui sarà vedere la disposizione del santo sepolcro, e il sito e la casa di Nostra Signora, considerandone specificatamente le varie parti, ossia la camera, il posto di preghiera, ecc”.(la traduzione è di Giovanni Giudici).
La citazione mi pare mostrare che nelle prime righe del romanzo ci sia qualcosa di simile a tale preambolo, abbiamo detto che “sono nella camera di mia madre” l’incipit del romanzo. Oppure queste prime pagine stanno a indicare una soglia che non abbiamo ancora varcato, potremmo vedere appunto nei primi capoversi una sorta di preambolo, una sorta di premessa alla narrazione, un avant prop: se ciò fosse vero allora il romanzo non inizia dove graficamente e editorialmente crediamo, la prima riga del racconto, ma una serie di capoversi dopo: “Non è questo il problema. Eccolo qui l’inizio che volevo io. Visto che lo conservano, deve pure significare qualcosa. Eccolo”. (p.498) Questo eccolo possiede in sé un carattere di ostentazione, con il quale il narratore mostra le sue intenzioni, a sottolineare: da qui in poi è il mio inizio. C’è un dato anche grafico, perché perché dopo “eccolo” troviamo il primo e unico punto fermo e a capo, ( questo almeno per le prime 50 pagine almeno sino a dove è giunta ad oggi la mia lettura). Questo segno grafico non può essere gratuito, segna uno passaggio di dimensione tra il testo scritto che l’Io narrante compila e ciò che accade successivamente. Che queste prime righe possano essere viste come preambolo, ovvero come momento che ritarda l’entrata in scena del romanzo, può essere evidenziato da un’altra particolarità. L’io narrante dice che un uomo viene a prendere i fogli che scrive ogni settimana, questo uomo viene ogni domenica e ha sempre sete (p.498) e critica l’Io narrante per come ha iniziato: “Ci ha ragione. Avevo cominciato dall’inizio, figuratevi, come un vecchio coglione” (p.498). Questo racconto non deve iniziare dell’inizio, cioè non deve iniziare dalla camera della madre, la camera della madre volendo è la fine, non l’inizio, questo personaggio il principio che ordina la narrazione dell’io, quello che prende i fogli, quello che monetizza i soldi. Dicevo mi colpisce che venga di domenica e abbia sete. Questo insistere sul principio, sull’inizio della storia, questo avere sete mostra qualche possibile connessione con il Vangelo di Giovanni: il prologo è dominato ovviamente dalla tensione del “principio”, del principio ordinatore di tutte le cose, il logos che è parola, ma è anche logica, ordine, una certa struttura del discorso e Gv 19, 28 dove appunto Gesù dice di aver sete. E se quindi a tutti gli effetti queste righe non fossero l’incipit, ma un prologo, un prologo a ciò che accadrà dopo, una sorta di anticipazione di quello che sarà; a ben vedere anche il prologo di Giovanni è così. Non c’è in questo prologo nessuna enunciazione di tempo, siamo un tempo presente a-storico, non sappiamo nulla di quando, come e perché l’uomo sia arrivato nella camera/spazio di sua madre, sappiamo che è morta, ma non sappiamo da quanto, ignoriamo il tempo preciso tra la morte della donna e la presenza dell’io narrante, come se tutto avvenisse sub specie aeternitatis.
Spazio terreste/spazio purgatoriale. Subito dopo eccolo troviamo queste due frasi: “Questa volta qui, poi penso ancora una, poi penso sarà finita, anche con quel mondo lì. È il senso penultimo” (p.498), mi soffermo su due cose. La prima è legata a comprendere cosa significhi “quel mondo lì”, logica vuole che indichi con questa definizione il mondo delineato nel preambolo, il mondo dell’uomo che viene ogni domenica, il mondo del non tempo, l’eternità, cioè l’Io narrante mostra una sorta di consapevolezza che esistano due piani, due mondi, uno lì e uno qua e che in qualche modo lui è stato compartecipe di entrambi: è chiaro che enunciare quel mondo lì significa che esiste una realtà che è qua, e non è casuale che appia da qui in poi una serie di descrizioni paesaggistiche: “La strada, dura e bianca, sfregiava i pascoli, saliva, scendeva, con i suoi avvallamenti. La città non era lontana” (p.499). Se il preambolo era claustrofobico, chiuso, qui abbiamo una apertura, il mondo qua è un mondo aperto, è un’isola, ha campi, strade, grandi spazi, “infide colline” (p.500), un mondo reale in cui i campi “s’imperlavano di rugiada”(p.502), un mondo di “sabbie, ciottoli, paludi, brughiere” (p.503). Con Beckett mi pare che più che una lettura sia una sorta di fatica di decrittazione, unire i puntini, provo ad elencarne alcuni: la natura “che pertiene a un’altra giustizia” (p.503), abbiamo visto la rugiada sui campi, l’io narrante se ne sta “appollaiato al di sopra del livello più alto della strada” (p.501), altre volte si trova “al sommo, o sui fianchi di un’altura considerevole” (p.506), “che ci faceva un’altura in un paesaggio a malapena ondulato?” (p.506), o sempre l’io narrante che sente “persino il belare di un gregge” (p.524). Che posto è questo? Che luogo? Un luogo terreno, con un’altura considerevole, che è di pertinenza di un’altra giustizia? A me ha ricordato con una certa chiarezza il Purgatorio dantesco, il gregge torna ad esempio in Pur III, il termine rugiada compare alcune volte proprio nella seconda cantica, l’altura considerevole è il monte stesso dove Dante ascende, e non paia strano che l’io narrante parli appunto di viaggio irreale (p.509) e quando parla della sua condizione dice: “oh non il fondo più profondo, da qualche parte tra la schiuma e il fango” (p.506) che ricorda la metafora del giunco schietto di Purg I. A confermare vediamo come la madre chiama l’io narrante: “Lei non mi chiamava mai figlio, del resto io non l’avrei tollerato, ma Dan, non so perché, non mi chiamo Dan. Magari Dan era il nome di mio padre” (p.509). Il nomignolo Dan suona simile a Dante e non è a questo punto casuale che troviamo nominati due personaggi centrali del purgatorio Sordello e, sopratutto, Belacqua (sul quale torneremo) che per Beckett rivestì in parte figura da alter ego. Se il luogo è il Purgatorio o una sua riscrittura in chiave moderna, mi pare altrettanto interessante il riferimento al tempo “penultimo” (p.499). Nel meridiano Frasca mette in evidenza come questo possa essere un dato strutturale, al tempo della stesura di Molloy SB aveva intenzione di scrivere un dittico di romanzi, che solo successivamente divenne una “trilogia” (alla quale secondo me non può essere disgiunta la scrittura e la composizione di Aspettando Godot). Se però questa penultimità del tempo avesse una serie di parentele proprio con questo fondo che non è completamente fondo, con una situazione di sospensione tipica d’altronde del purgatorio e del purgatorio Dantesco. Che il romanzo, che il genere romanzo, abbia a che fare con tema purgatoriale, con al sospensione del tempo l’ho già dichiarato in un intervento pubblicato da La ricerca (1, 2), ma qui mi pare interessante indagare proprio cosa sia il senso penultimo, quasi SB decidesse che la letteratura non può essere apocalittica, non può essere rivelatrice dei novissimi – cosa sarà di noi dopo la morte, cosa sarà del mondo dopo la fine del tempo -, ma che si debba accontentare di una sorta di presa d’atto dell’assurdo di ciò che accade qui di giorno in giorno e che sì ecco si mostra in tutta la sua potenza nella battuta che Dante fa pronunciare a Belacqua nel Purgatorio e che secondo me riassume la poetica di SB e il suo atteggiamento verso il mondo e la storia: “O frate, andar in su che porta?” (Pur IV, 127). Il tempo penultimo è una di tempo di “divina indifferenza” montaliana, uno sguardo di colui che è sopravvissuto, fortunato di non aver partecipato se non marginalmente agli orrori e agli errori della seconda guerra, ma di cui ne porta in sé la cicatrici.
L’Io narrante è l’uomo che è sopravvissuto ad Auschwitz senza essere stato in Auschwitz, che porta su di sé quelle cicatrici, ma che non le ha esperite completamente. Il romanzo pullula di riferimenti scatologici al basso, al crasso, al culo, alla cacca (pp.503; 505; 510; 511; 512 e potrei continuare), mi sono chiesto se questo potesse avere a che fare con il lager come anus mundi come il buco del culo del mondo, luogo in cui tutto su coagula. Mi colpisce rispetto a questo un accenno che l’Io narrante fa nella descrizione della sua “prigionia” della casa della signora con il cagnolino. L’Io narrante vive una sorta di condizione costrizione all’interno di questa villa, la sua residenza ha qualcosa di strano e di costretto; potrebbe sembrare, e come qualcuno nel nostro gruppo ha fatto notare, che sia l’Io narrante sia sotto la prigionia di Circe rivisitata e che quindi questo interno di inferno borghese sia una sorta di omaggio all’Ulisse di Joyce e al suo Bloom preso nelle spire della squallida vita quotidiana. Ciò è sicuramente vero, la complicata struttura delle casa che ricorda certe abitazioni dei romanzi ottocenteschi (la complicata architettura degli interni di Balzac, o Dostoevskij o Dickens), ma nello stesso tempo ad un certo punto leggo questa frase (sono convinto che SB debba essere letto per frasi, quasi singole, dimenticando la struttura meramente narrativa della storia): “Quel famoso sentore di mandorle, per esempio, non sarebbe bastato a levarmi l’appetito” (p.555). Perché il sentore di mandorle è famoso? Perché SB non scrive “il sentore di mandorle et et”? L’aggettivo famoso quindi ci dice qualcosa di pregante, e perché è collegato al mondo concentrazionario? Basta fare una semplice ricerca su google o aver letto un po’ di saggi sull’argomento per sapere che proprio il profumo e il sentore di mandorle è quello che lo Zyclon B rilasciava una volta venuto a contatto con l’ossigeno. Il tempo penultimo di Molloy è quindi, a parer mio, il tempo della sopravvivenza senza l’esperienza del limite, è il tempo del gioco, della recita, facciamo finta che “il mondo finirà”, ma nelle realtà il mondo è già finito.
Uomo “non”. Vengo all’ultima riflessione, mi riprometto ovviamente in questi appunti di andare e tornare indietro alle pagine già lette. Che tipo di uomo è l’uomo di SB o almeno come appare in queste prime pagine? La mia idea è che l’uomo sia definito per litote. Leggo sul dizionario: “Formulazione attenuata, ottenuta mediante la negazione del contrario”; insomma invece di dire buono diciamo “non cattivo”, e mi pare abbastanza chiaro che le due affermazioni non siano medesime. E come appare l’uomo del tempo penultimo in queste prime pagine? Intanto non credo che sia casuale che i primi due personaggi, oltre all’Io narrante e alla madre che compaiono le preambolo, vengano identificati da lettere: A e B nella versione italiana e francese e A e C in quella inglese, tralascio per un attimo i significati che possono esserci dietro, intorno, ai lati di questi due primi personaggi, ma il fatto che camminino e si muovano lungo un dato percorso mi hanno ricordato una sorta di “vettore” o di segmento che indica una direzione, il segmento A e il segmento B o C, l’uomo è ridotto alla sua traiettoria, è pura traiettoria all’interno di un paesaggio, come se fosse diventato sottile, e avesse perduto le molte sue qualità e caratteristiche, non parliamo neppure più di personaggio tondi o piatti, qui li abbiamo vettoriali: ridotti a movimento. Proseguendo la nostra lettura troviamo: “Io non – io non mi sentivo infelice” (p. 514). Compare quindi la litote (figura retorica che anche Svevo ne La coscienza di Zeno predilige, mi torna alla mente Storia del mio matrimonio), ancora una volta è importante leggere la frase per intero, e soffermarci sull’inizio sul quel “io non” seguito da un segno grafico. Sembra quasi un linguaggio computazionale: Io non – x, dove x può indicare qualsiasi qualità umana, ma l’uomo si è ridotto a una formula a una semplice “negazione” di qualcosa, l’uomo è una sorta di parodia, di negazione, di Dio, se è fatto a somiglianza Dio e Dio non c’è, o Dio è questa sorta di noluntas, di non volontà di essere niente, allora l’uomo è un “non” che precede qualsiasi caratteristica. E infatti: “Quello che amavo della antropologia, era la sua forza di negazione, il suo accanimento a definire l’uomo, seguendo il modello di Dio, in termini di ciò che non è” (p.537). C’è già quindi in Molloy l’uomo beckettiano che leggeremo in Finale di partita, o nell’Ultimo nastro.