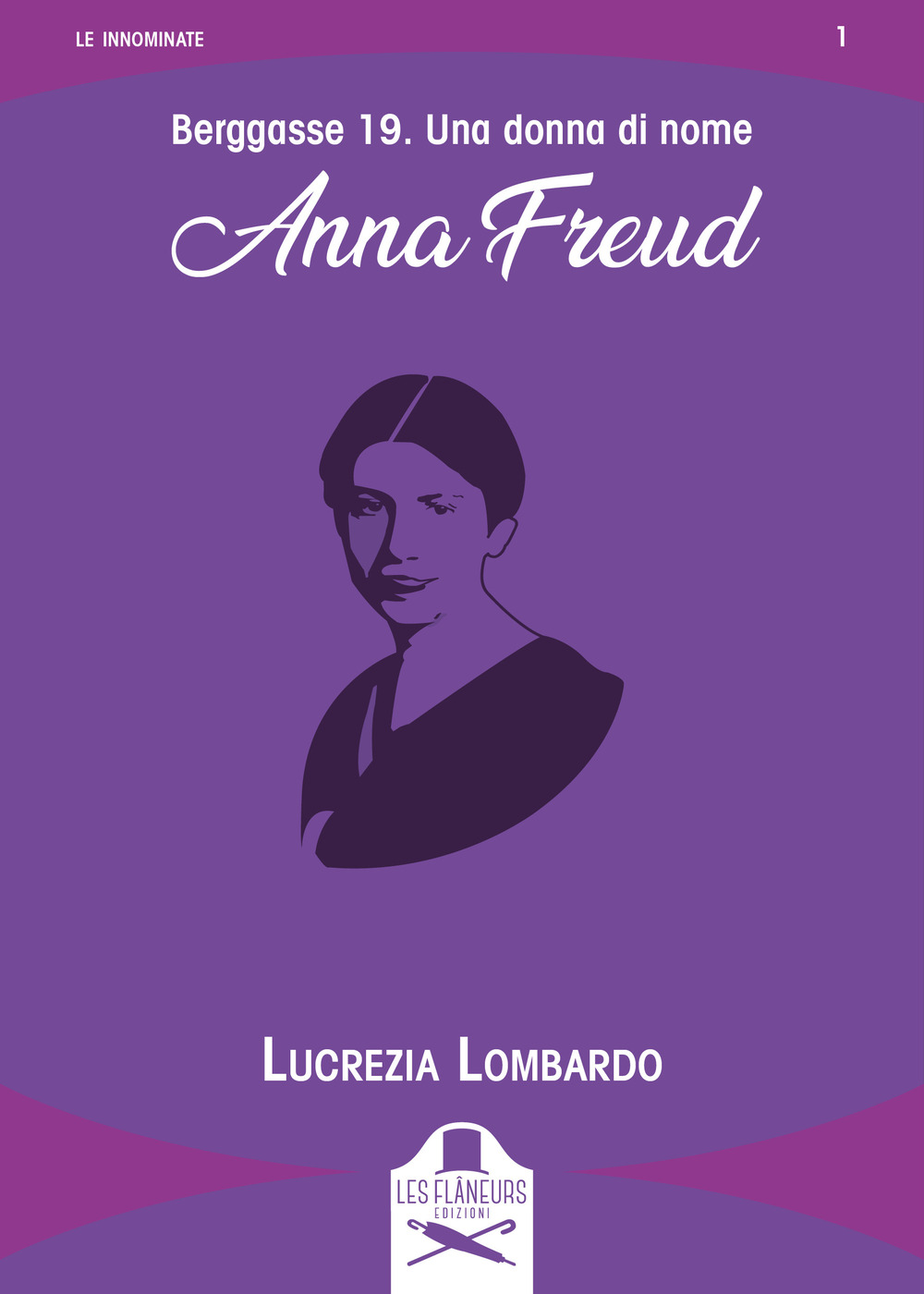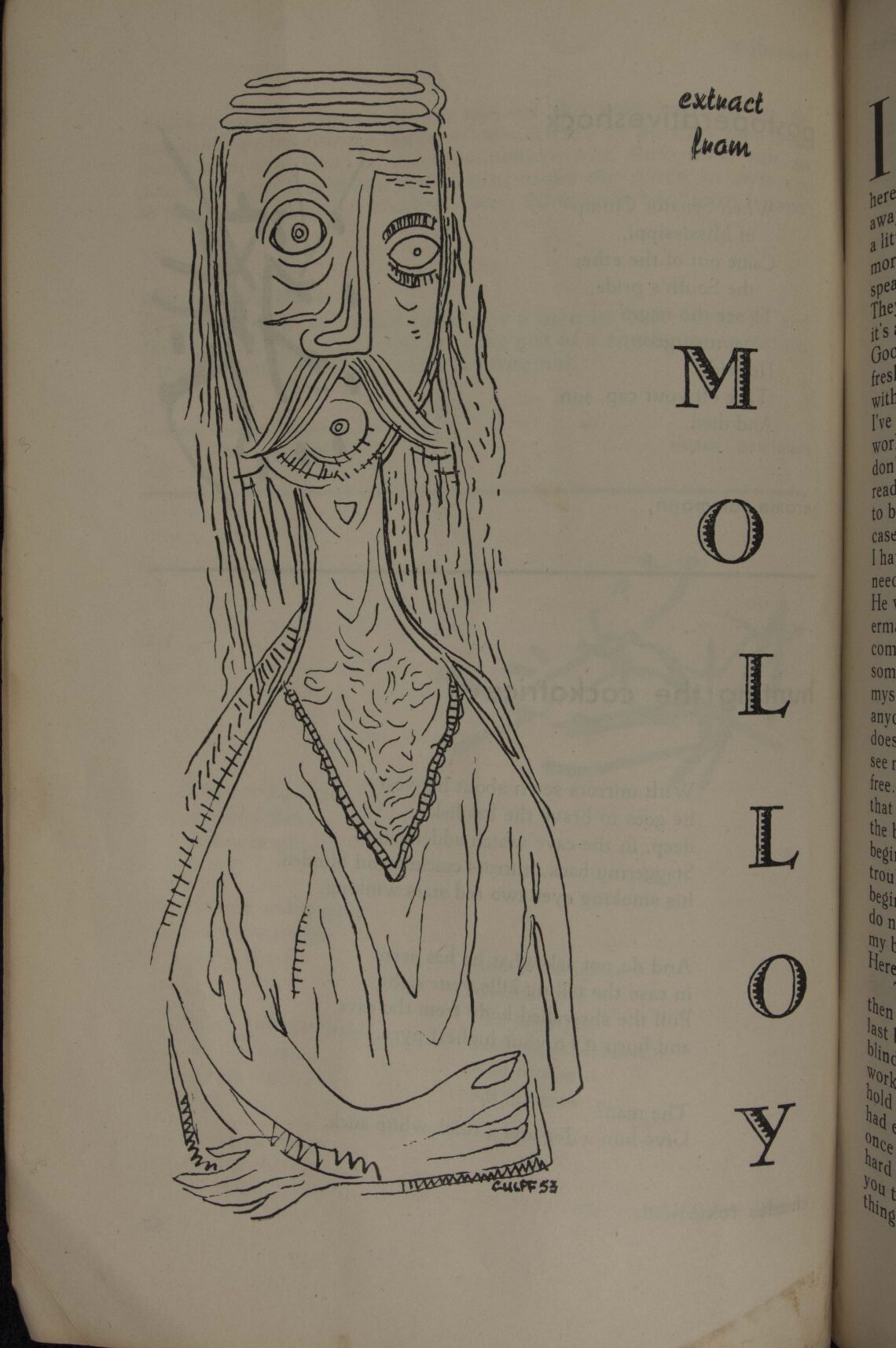di Demetrio Paolin
[le pagine citate nel testo si riferiscono al meridiano Mondadori, Samuel Beckett Romanzi, teatro e televisione a cura di G. Frasca]
La strana fine di Molloy. Le ultime pagine della prima parte sono dominate dall’ingresso di Molloy in un bosco, in cui il protagonista – nel tentativo di andare dalla madre – si addentra e qui il cammino di Molloy si arresta. “La selva era tutt’intorno a me e i rami, intrecciandosi a un’altezza prodigiosa, in rapporto alla mia, mi proteggevano dalla luce e dalle intemperie” (p.592). Questa selva non è oscura, altrimenti sarebbe la selva infernale, infatti lo stesso Molloy sostiene: “Dire che brancolassi in tenebre impenetrabili, no, non posso proprio” (ibidem). Nella selva regna una sorta di “ombra bluastra” (ibidem) più che sufficiente per rischiare il cammino del protagonista, proprio come un personaggio dantesco, nella selva Molloy fa una serie di incontri, diversi dice Molloy, ma ce ne racconta uno solo quello con il carbonaio (p.593) che si conclude con l’uccisione dello stesso. Pare sempre, questo è reso evidente anche nella seconda parte, che ogni incontro debba concludersi con una morte, spesso accennata, raccontata come inevitabile e banale. La selva diventa per Molloy una sorta di prigione, di luogo dal quale non può uscire: “E tanto più mi sembrava auspicabile uscire dal più presto da questa selva in quanto sarei stato fin troppo presto nell’impossibilità di uscire da ovunque mi trovassi, fosse pure un boschetto” (p.599). Il cammino di Molloy diventa faticoso, uno sprofondare all’interno della terra, della selva. Infine “giunse il giorno in effetti in cui la selva finì e vidi la luce della pianura” (p.601), il viaggio di Molloy sembra destinato a concludersi, ma in realtà l’uomo cade, decide di abbandonarsi?, in un fossato: “Mi lasciai ruzzolare fino al fondo del fossato” (p.602); qui come in altri punti nel momento di massima debolezza, di deposizione dell’umano, dell’arrendersi dell’uomo al suo essere niente avviene una sorta di commistione, di trasformazione con l’ambiente circostante: “Mi sembrava di sentire gli uccelli, forse delle allodole. Era tanto che non li sentivo. Com’era possibile che non li avessi sentiti nella selva? Né visti. Allora non mi era sembrato strano. (ibidem). La caduta nel fossato è una sorta di nostos al grembo materno? Forse proprio il fosso, la sepoltura in vita, in regresso alle origini, sono alla base del viaggio e della fine di Molloy, Molloy deve tornare alla madre, ma la madre è la terra, è la selva che lo ha protetto come quando era nel grembo: “Avevo voglia di tornare nella selva” (p.603).
Abramo e Isacco. Dal punto di vista della lettura la seconda parte del romanzo è più usuale, Beckett usa una serie di stratagemmi, di strutture, di modi che ricordano il giallo e il noir. Moran ha un po’ i modi spicci, le malinconie e le ubbie di tanti detective privati di certe letture noir: l’indolenza, la aggressività passiva nei confronti della sua missione, la meticolosità dell’organizzazione del viaggio, lo sguardo sconfortato rispetto all’umanità che si trova a frequentare lo rendono molto simile allo stereotipo di quel tipo di personaggio. Dal punto di vista squisitamente narrativo: abbiamo Moran che deve andare a cercare Molloy. È un lavoro come un altro, il dialogo con Gaber sembra un canovaccio che Moran conosce sa cosa dirai lui e cosa gli risponderà emissario, ma ad un tratto qualcosa di nuovo accade. “Suo figlio l’accompagnerà, disse Gaber. Tacqui. Quando le cose si fanno serie noi tacciamo” (p. 608). L’entrata in scena del figlio modifica l’intreccio del racconto. Non c’è nessun motivo particolare perché il figlio debba seguire il padre in questa avventura, pare infatti un capriccio di Gaber e del datore di lavoro di Moran. Il rapporto tra padre e figlio è un rapporto che non esiteremmo a definire sadico, il padre punisce, accusa attacca il figlio di cui spesso non sentiamo neppure la voce. Il figlio è una sorta di proiezione del padre sin da nome identico. L’aggiunta quindi di questo personaggio, quasi per capriccio, è a tutti gli effetti il romanzesco, o meglio è ciò che rende queste pagine un romanzo: non c’è nessun motivo per cui il figlio segua il padre, perché faccia parte di questa spedizione se non per il fatto che solo il questo modo l’incarico del padre può diventare un romanzo. Il romanzesco, spesso, non sempre, è proprio il gratuito accadere delle cose all’interno di una congerie di fatti logicamente uniti gli uni dagli altri. Pensiamo anche alla prima parte, al muoversi di Molloy, ci sono motivi concreti per cui egli si sposti nel tempo e nello spazio? No. Perché va all’avventura? No, non rintracciamo nessuno motivo fondamentale e/o logico. Semplicemente ci viene detto che Molloy deve andare dalla madre, così come Moran deve portare il proprio figlio con sé. Vista in questa luce anche la presenza di Gaber assume una sfumatura nuova e diversa: egli è un messaggero che porta un annuncio per la partenza della missione, è anche colui che dice a Moran che può tornare a casa (p.693). Gaber porta i messaggi di Youdi, personaggio di cui Frasca – nelle note al romanzo – ne spiega l’origine: “Dieu/Ideu/Udie” (p.1669). C’è un “Dio” che manda un suo messaggio per dire a un padre di mettersi in cammino con suo figlio; credo che sia abbastanza chiaro il riferimento all’episodio di Abramo e Isacco e all’ipotetico sacrificio di quest’ultimo. Il figlio è un Isacco perfetto, ignaro del motivo di questa avventura fuori casa, cosa di cui il padre è perfettamente consapevole: “Perché sapevo quello che ancora lui non sapeva, fra le altre cose che una simile prova gli sarebbe stata utile” (p.627). Il cammino di Moran e del ragazzo, quindi, ha una valenza diversa e avviene nel nome del padre, così come quello di Molloy è avvenuto nel nome della madre (non ho idea se parte prima → fase anale e parte seconda → fase genitale abbiano a che fare con questo diverso punto d’arrivo). Per Moran la ricerca di Molloy che dovrebbe essere la spinta al cammino è, però, spesso oscurata dai rapporti con il figlio, con le schermaglie con esso: Molloy è un pretesto. Così come Abramo si alza di prima mattina e parte con Isacco così fa Moran, egli non dubita mai di quello che deve fare, perché ciò che Gaber gli annuncia, cioè la parola Youdi, è sempre la verità. La scomparsa del figlio di Moran alla fine del libro e la solitudine del padre sono il segno della vicinanza tra l’episodio biblico e la seconda parte del romanzo. Infatti il centro dell’episodio della Genesi non è il sacrificio, ma la fede di Abramo, l’obbedienza cieca ai voleri di Dio, Isacco è un semplice oggetto della narrazione, il motivo gratuito, romanzesco, per mettere alla prova Abramo, per questo motivo infine lui è inconsapevole di ciò che sta per accadere e che solo l’angelo ferma. Allo stesso modo in Molloy tutta la consapevolezza di ciò che accade è nel padre, che come Abramo porta il peso di questa scelta.
Moran → Molloy. C’è nel romanzo una trasformazione interessante. Verrebbe da dire che ogni romanzo è romanzo di formazione ovvero prevede e ipotizza che il personaggio principale si formi, si trasformi da ciò che non è a ciò che è: è una apprendimento di consapevolezza, che alcune volte è felice (pensiamo a Renzo nei Promessi Sposi) e altre volte è infelice (il triste finale di Don Chisciotte). Anche in Molloy assistiamo a qualcosa di simile o meglio alla messa in scena di questa formazione: Moran nel corso delle pagine lentamente, senza che alcuno ne abbia contezza, si trasforma in Molloy, il problemi di deambulazione, la ricerca della bicicletta. Come se il ricercatore diventasse tutt’uno con il ricercato, l’inquisitore con l’inquisito e l’omicida con l’ucciso (forse l’omonimia tra padre e figlio potrebbe essere un indizio di tale convergenza?) questo passaggio è tale che ci conduce a sviluppare una serie di ragionamenti. Dobbiamo, secondo me, rispondere ad alcune domande legate allo statuto del racconto che abbiamo davanti, forse non abbiamo a che fare con due personaggi (due Io che parlano), ma con ben altro.
Moran = Molloy. Ricapitoliamo: nella prima parte abbiamo un personaggio, Molloy, che scrive la sua storia; ciò che ci è dato di sapere che è arrivato nella camera di sua madre, si pensa in ambulanza, forse qualcuno l’ha raccatto nel fosso dove si conclude la narrazione della prima parte. Nella seconda parte abbiamo un personaggio, Moran, che scrive la sua storia, per ciò che sappiamo è stato inviato a cercare Molloy, la sua ricerca è infruttuosa, così viene invitato per tornare a casa e una volta rientrato si mette a scrivere. Sappiamo che lentamente Moran ha assunto alcune delle caratteristiche fisiche di Molloy, la zoppia su tutti e il suo spostarsi in bici. Non abbiamo nessun dato reale che Molloy esista, perché l’unico che potrebbe raccontarci qualcosa di lui, Moran, è stato mandato prima a casa e scrive un rapporto. Il racconto di Moran è ordinato: si sviluppa in senso cronologico (l’arrivo del messaggero, i preparativi, il viaggio, la crisi, il nuovo apparire del messaggero che intima il ritorno et et). Sappiamo che il racconto di Molloy (vd appunto precedente) possiede, invece, un doppio inizio: “Avevo cominciato dall’inizio, figuratevi, come un vecchio coglione” (p.498). Potremmo anzi supporre che esistano due racconti, il primo che Molloy consegna all’uomo della domenica, e l’altro che leggiamo noi. Quindi abbiamo un racconto che inizia dall’ “inizio”, ma che è posto in seconda battuta, e un racconto che non inizia dall’inizio, ed è la prima cosa che il lettore legge. A questo punto possiamo provare a elaborare un’ipotesi: le vicende di Moran sono antefatto di ciò che leggiamo prima (la storia di Molloy). Ciò che noi leggiamo come una testimonianza di Molloy altro non è che il racconto che, alla fine del romanzo, Moran inizia a comporre. Se così fosse, questa struttura ricorda molto da vicino la struttura della narrazione nella Recherche di Proust: le pagine conclusive dell’opera ci narrano del protagonista, che prende la decisione di scrivere il romanzo che noi abbiamo appena finito di leggere. E se quindi fosse Molloy fosse una invenzione di Moran?
Uno strano io. Molloy, come romanzo, pone in maniera radicale la difficoltà di spiegare cosa indichi “io” in narrativa. In primo luogo entrambe le parti che compongono il romanzo sono scritte in prima persona: questo dal punto di vista grammaticale è facilmente individuabile, ma rimane molto più complesso scoprire cosa si nasconda dietro questo lemma “io”. Il pronome “io” fa nascere una catena di interrogazioni: Chi è il vero io di questa storia? chi è che fa dire io a Molloy e io a Moran, essi sono due “io” diversi o sono il medesimo “io”. Possiamo provare a fare due ipotesi.
a) Part I → Molloy → io: Molloy e Part II → Moran → io: Moran.
b) Part I →Molloy → io→ Moran: Molloy e Part II→ Moran → io: Moran, che sottintende la trasformazione di Moran in Molloy, e la strana struttura ciclica della narrazione.
Durante il racconto Moran inizia a parlarci dei suoi casi, che Youdi gli ha affidato, e nel parlare di questi li definisce “storie” (p.660) e aggiunge: “Che turba nella mia testa, che galleria di crepati. Murphy, Watt, Yerk, Mercier” (ibidem). I personaggi delle storie/casi di Moran sono tutti i personaggi delle opere precedenti di SB. Moran continua dicendo: “Storie, storie. Non ho saputo raccontarle. Nemmeno questa avrò saputo raccontare” (ibidem). Questo potrebbe portarci a un’altra riflessione: se questo io che scrive io non fosse né Moran né Molly, ma fosse SB che, tramite Molloy e di Moran, mostra il meccanismo del romanzo, nel quale un personaggio postula il fallimento dello stesso meccanismo che viene descritto. L’autore ci suggerisce come io sia un solo un pronome, che può scivolare nell’egli.
Le voci e egli. Molloy è scritto in prima persona, questa affermazione è vera tranne che per una eccezione, un periodo che chiude la prima parte, vediamolo insieme: “Mi sembrava che piovesse, ci fosse il sole, a rotazione. Un vero e proprio tempo primaverile. Avevo voglia di tornare della selva. Oh non proprio voglia, per davvero. Molloy poteva restare lì, dov’era.” (p. 603). C’è questo passaggio repentino tra la prima persona e la terza, senza nessuna segnalazione di questo movimento. Mentre leggiamo viene da chiederci: Chi pronuncia/scrive questo ultimo enunciato? Il narratore? Possiamo escluderlo, perché appunto il narratore è in prima persona. È un intervento dell’autore? Anche rileggendolo non sembra uno di quei momenti tipici dei romanzi ottocenteschi, nei quali l’autore prende la parola e discute con i lettori [in Molloy, infatti, quando il protagonista vuole chiamare il causa il lettore, non ha problemi a farlo direttamente: “Voi mi direte che questo fa parte delle mie storie…” (p. 589)].
L’effetto di tale chiusa, quindi, è di costringerci a guardare Molloy dall’esterno e dell’alto (non dobbiamo dimenticare che in queste ultime pagine il protagonista è supino in un fosso): qualcuno dice che, infine Molloy, può restare dov’è. Di chi p questa voce che è estranea al romanzo? L’enunciato è una sorta di ordine: Lasciamo Molloy lì dove sta, come se non lo dicesse tanto a noi lettori, quanto a colui che scrive. È una voce esterna che detta i comportamenti a colui che scrive, una voce esterna e al narratore e l’autore.
In Molloy, sia nella prima parte che nella seconda, leggiamo spesso di voci, che i personaggi dicono di sentire e di avvertire lungo il loro cammino. Leggiamone alcuni passi: “Perché io mi sono tanto sottratto, sempre, tanto sottratto ai miei suggeritori” (p.597), oppure qualche pagina dopo leggiamo: “E ogni volta che dico, Io mi dicevo questo o quell’altro, o parlo di una voce interiore che mi diceva, Molloy, e poi una bella frase più o meno chiara e semplice, o mi ritrovo a prestare a terzi parole intelligibili”(p.598). Molloy racconta di avere nella sua testa, dentro di sé o intorno a sé, questo non ci è chiaro, dei suggeritori, di avere una voce che gli parla e gli detta parole. Il tema della voce diventa ancora più presente nella seconda parte, Moran ci suggerisce: “Se vi piace, è una voce abbastanza ambigua e non sempre facile da seguire, nei suoi ragionamenti e decreti. Come che sia la seguo, più o meno, la seguo in questo senso, che la comprendo, e in quest’altro senso, che le obbedisco” (p.654) e infine aggiunge: “Ho parlato di una voce che mi dava delle istruzioni, o meglio dei consigli. Fu durante quel ritorno che la udii la prima volta” (p.700). Questi due personaggi, che sono i due io che narrano, raccontano una sorta di svuotamento: non sono loro che agiscono, ma qualcuno che detta loro come comportarsi, sono passivi. Se è vero che Moran è il narratore della prima e autore della seconda parte, che è narrata da Molloy, entrambi sono accomunati da una sorta di inoperosità. Questa voce che detta i comportamenti, che li svuota di ogni volontà propria, che è superiore a ogni sentimento umano, a ogni passione, che anzi svilisce tali passioni, è molto simile a quella che Dante descrive in Purg. XXIV: “E io a lui: «I’ mi son un che, quando/ Amor mi spira, noto, e a quel modo/ ch’e’ ditta dentro vo significando»”. Anche Dante, il Dante dello stilnovo, racconta la scrittura come una sorta di dettatura, di uno svuotamento di sé, per essere riempiti d’amore, schiavi e servi d’amore. Pensiamo solo all’incipit della famosa canzone della Vita Nova “Amor che ne la mente mi ragiona” che potremmo parafrasare come una sorta di possessione in cui è Amore che ragiona e ha preso possesso della mente del poeta. L’amore è uno svuotamento dell’uomo, che nel momento in cui prova Amore previene a una sorta di noluntas, come la descriveCavalcanti in uno dei suoi sonetti più famosi: “I’ vo come colui ch’è fuor di vita,/che pare, a chi lo sguarda, ch’omo sia fatto/di rame o di pietra o di legno,/che si conduca sol per maestria/e porti ne lo core una ferita che sia,/com’ egli è morto, aperto segno.”. La condizione di Moran e di Molloy è simile: entrambi sono “fuor di vita”, entrambi sono un uomo che non pare reale ma “fatto di rame o pietra”. C’è un qualche legame tra questa “prepotenza” descritta da Dante e Cavalcanti e l’egli che prende la parola e intima di lasciare Molloy lì dove sta e che detta e suggerisce la storia a Moran? E sopratutto chi è questo egli?
egli o Egli?. Per rispondere all’ultima domanda che ci siamo posti partiamo da una citazione di Denis De Rougemont da L’amore e l’occidente, lo scrittore francese analizzando Tristano e Isotta nota come molti degli accadimenti del romanzo siano gratuiti, siano creati dall’autore stesso: “quando non vi siano ostacoli, se ne inventano”, perché esiste un “fenomeno che accomuna il romanziere e il lettore, […], una sorta di complicità che li leghi: la volontà che il romanzo continui, o per così dire, scatti in avanti”. Questa volontà, che desidera che il romanzo proceda, che le complicazioni si moltiplichino, che le scene si susseguano, è il demone del romanzesco, che “in fondo è tutt’uno” con il demone dell’amore cortese, “poiché il demone dell’amore cortese ispira il cuore degli amanti da cui nasce il loro soffrire, è il demone del romanzo come piace agli occidentali”.
Tale coazione al procedere del racconto è così pervasiva che leggendo Molloy si ha l’impressione di trovarsi in una struttura narrativa simile a Tristano e Isotta. Sia chiaro non ci sono episodi comuni o simili, ma è il modo con cui si sviluppa la narrazione a sembrarci simile; infatti nel romanzo cortese le scene che si succedono, germogliano per creare complicazioni, e con esse una maggiore sofferenza, ostacolo che differisce e allontana l’amore totalizzante. Similmente in Molloy le scene si susseguono non tanto per logica narrativa, ma per semplice differimento della fine, quasi SB avesse in mente l’origine della letteratura occidentale, una letteratura che postula come origine l’infelicità, sempre De Rougemont: “Il prodigioso successo del romanzo di Tristano rivela in noi, lo si voglia o meno, una intima preferenza per l’infelicità”. I personaggi dei romanzi, proprio come in Molloy, “sono attratti dalla morte, lontani dalla vita”. Il tema dell’amore nel romanzo cortese, però, nasconde, proprio come racconta De Rougemont, qualcosa di più complesso: dietro la retorica e la narrativa d’amore c’è una vertigine religiosa, c’è la sopravvivenza di una ideologia popolare e ben più antica di quella cristiana. L’amore cortese per lo scrittore francese è una sorta di metaforizzazione di un di un Dio che “si libra al di sopra del cielo”: esso mostra “già la stessa Divinità dei grandi mistici eterodossi, il Dio che precede la Trinità di cui parlano la gnosi e maestro Eckhardt, e più precisamente ancora, il Dio ‘sopraessenziale” che secondo Bernard de Chartes risiede al di sopra dei cieli”. A spiegare questa dismisura che precede il mondo, che precede Dio stesso, ci sono le parole di Bernard De Ventadour, che avrebbero potuto essere pronunciate da un personaggio di SB: “M’ha tolto il cuore, m’ha tolto il mondo, m’ha tolto a me stesso; e infine si è sottratta anche lei, lasciandomi solo con il mio desiderio e il mio cuore assetato”.
Questo Dio che sfugge a ogni definizione è al centro di Molloy della sua inchiesta, e non perché non penso né credo che Molloy sia un romanzo teologico, ma perché è il romanzo che si interroga sulle cose “penultime”, come bene lo si intravede nella nella domanda 13 di Moran: “Che cazzo faceva Dio prima della creazione?” (p.697). Questa domanda è centrale per comprendere lo sguardo di SB: cosa c’è prima della creazione, cosa è il principio che genera il mondo?
egli → Egli → Nulla. Potremmo rispondere, riprendendo la riflessione sulla litote che avevamo fatto (vd appunto precedente). Il “non” è centrale per comprendere la descrizione dell’uomo in SB. L’uomo, nell’universo di Molloy, è condannato a vita assurda, pensiamo alle lunghe elucubrazioni di Molloy rispetto ai suoi sassi (pp.578-579), che riprendono certamente Il mito di Sisifo di Camus (1942), e non è causale che il riferimento all’eroe mitologico sia ripreso, quasi in un gioco di specchi, nella seconda parte da Moran: “Ma persino a Sisifo non penso che sia imposto di grattarsi, o di gemere, o di esultare…”(p.655). L’uomo di Molloy ha perduto la speranza, ha la disperazione come orizzonte principale: “Questo alimenterebbe la sua speranza, non è così, la speranza che è la disperazione infernale per eccellenza” (ibidem). L’orizzonte assurdo in cui l’uomo vive è un orizzonte di nullità, di nullafacenza, di non agire: “Perché non è nulla, non sapere nulla, né tanto meno non voler saper nulla, ma non poter saper nulla, sapere di non poter saper nulla, ecco dove trascorre la pace, nell’animo del ricercatore curioso” (p. 568). Oppure la negazione di Moran nel momento in cui Gaber gli intima l’ordine di tornare a casa: “Non posso camminare, dissi. Come?, disse lui. Sto male, non mi posso muovere, dissi. Non intendo una sola parola di quello che dice, disse. Gli gridai che non potevo spostarmi” (p. 692). Questa negazione dell’umano, dell’essere umano, è totalizzante tanto che alla fine del romanzo Moran dichiara: “Non sopporterò più di essere un uomo, non ci proverò più. Non accenderò più questa lampada” (p.707). L’umanità definita tramite il “non”. Mi pare interessante qui sottolineare una strana convergenza, tra due autori non facilmente accostabili, ma che secondo me è invece centrale. L’immagine di Moran come sicario o similare mi porta a mettere a fianco Molloy e I 49 racconti di Hemingway, pubblicati nel 1938, in particolare il racconto I sicari. La vicinanza tra questo racconto e Molloy è secondo me evidente, da un lato abbiamo appunto l’atmosfera noir con i due sicari, duri, sadici, strafottenti, ma che infine falliscono, che ricordano in parte il Moran del romanzo di SB, ma be più interessanti sono a mio parere le parti finali del racconto in cui compare Ole Anderson, il bersaglio dei due killer. La sua apparizione modifica profondamente il racconto, nella prima parte era stato sincopato e ansioso, la sua entrata in scena è invece all’insegna della negazione. Nel dialogo tra lui e Nick Adams il numero delle negazioni è altissimo: “- Non posso farci niente – disse Ole Anderson.// – Le dirò che aspetto avevano. // – Non voglio sapere che aspetto avevano. […] // – Non vuole che vada a dirlo alla polizia?// – No, – disse Ole Anderson – Non servirebbe. // – Non c’è niente che possa fare?// – No. Non c’è niente da fare”. Il mondo di Hemingway e quello di SB hanno in comune questo dominio del nulla, del niente che avvolge e costringe tutti i personaggi: il destino di ogni uomo è infine negazione.
Ora forse possiamo provare a rispondere alla domanda di Moran. Che cosa faceva Dio prima della creazione? Dio prima della creazione faceva nulla, Dio era nel nulla, era attraversato dal nulla. La risposta migliore è, quindi, nella preghiera che Moran recita: “Padre nostro che non sei né in cielo né in terra né all’inferno, né voglio né desidero che sia santificato il Tuo nome, a Te è dato di sapere quello che ti conviene” (p. 697). Il Dio che prega Moran è un Dio indefinibile, comprensibile solo per via negativa, le parole di Moran sono molto simili a quelle del protagonista hemingwaiano di Un posto pulito e illuminato bene : “Era un niente che conosceva troppo bene. Era tutto un niente, e anche un uomo era niente. […] lui sapeva che era tutto nada y pues nada y nada y pues nada. Nada nostro che sei nel nada, nada sia il nome tuo il regno tuo nada sia la tua volontà nada in nada come in nada. Dacci questo nada il nostro nada quotidiano e nadaci il nostro nada come noi nadiamo i nostri nada e non nadarci in nada ma liberaci dal nada, pues nada. Ave niente pieno di niente”. La vicinanza tra le due preghiere è fortissima, entrambe mettono in evidenza qualcosa che precede l’uomo, la creazione e Dio stesso: il mondo, l’uomo, ciò che c’è prima dell’uomo e del mondo, quindi Dio stesso, è niente, avvolto nel niente e risolto nel niente; questa nothingness è l’egli che detta i movimenti dei personaggi di Molloy. Il mondo descritto da SB in Molloy è il mondo del nulla, il mondo che non solo è andato in frantumi, tali frantumi stanno scomparendo: non esiste più bellezza, natura, amore, sentimento, ma solo un nulla enorme che avvolge tutte le cose. Per quanto riguarda SB, Adorno parla di “nulla positivo”, il nulla delle opere beckettiane non è una semplice negazione, ma è l’esistenza di una negazione, e il comprendere che il “non essere” è comunque, che in qualche modo esiste ed è il prodotto di questa nostra vita e nostra storia. Nella lingua francese la parola “niente” può essere resa con “rien”, che mantiene al suo interno memoria della parola latina res/cosa; e quindi rien dice niente dicendo “cosa”, rien suggerisce che esiste una cosa che è niente, che il niente non si oppone all’essere, ma ne è involucro.
Si può vedere il niente, il niente è qualcosa, perciò è positivo, possibile, dicibile: la scrittura di SB per Adorno è tutta in questo sforzo: “Qualcosa che potrebbe definirsi come il tentativo di raggiungere un nulla positivo e cioè un nulla che non possa essere inteso che come negazione di qualcosa che esiste. Tutta l’indescrivibile energia di questo scrittore non fa che gravitare attorno a questo stesso punto facilmente spiegabile dicendo che il nulla non può essere pensato né immaginato se non come il nulla di qualcosa. […] non è logicamente concepibile che il nulla sia altro che il nulla di qualcosa”.
Il finale. “Allora rientrai a casa e scrissi, È mezzanotte. La pioggia batte contro i vetri. Non era mezzanotte. Non pioveva” (p. 707). La frase suona stravagante, sembra negare qualcosa che ha poco prima affermato. C’è in questa chiusa, a parer mio, una possibile descrizione della poetica di SB. In primo luogo possiamo notare che le due frasi sembrano uguali, ma non lo sono. La prima cosa che ci colpisce è l’alternanza tra presente e imperfetto: gli enunciati affermativi sono al presente, quelli negativi sono all’imperfetto. Tale slittamento grammaticale mette in risalto la differenza, ci mette davanti a uno stridore, SB vuole mostrarcelo, così come nella fine della prima parte aveva introdotto la stortura del passaggio dalla prima alla terza persona, come ad avvertici del dato teologico che avremmo visto più pienamente nella seconda parte.
Nella chiusa del libro l’autore vuole suggerici di guardare un evento che si conclude tutto nel linguaggio. Moran entra in casa e scrive “è mezzanotte”/“piove”, ma ciò non significa che realmente stia piovendo e che sia realmente mezzanotte. E infatti le due frasi successive sembrano suggerire: ho scritto che “piove” e “è mezzanotte”, ma in realtà mentre scrivevo tali parole, che hanno per significato “piove” e “è mezzanotte”, non stava né piovendo né era mezzogiorno.
SB ci suggerisce che non esiste la verità in letteratura, che ciò che leggiamo è un’illusione linguistica, una combinazione di parole; il mondo è andato, è svanito, lasciando appena ombre e macerie; la letteratura non ha più la forza di produrre qualcosa di vero e di reale, ogni sforzo in questo senso è ormai vano; la letteratura non può che mostrare l’assurdo di ciò che è, e di ciò che ci pare essere; lo scollamento con la realtà è totale: io posso scrivere una cosa assolutamente logica e corretta, ma ciò non significa che sia vera o reale. La letteratura è altra rispetto al reale. Proprio a ragione di ciò Moran può entrare in casa e scrivere frasi che per quanto grammaticalmente e logicamente vere non sono per forza reali.
Esiste la realtà e esiste la realtà nel linguaggio: le due tensioni non sempre coincidono, anzi lo scrittore vive proprio nel mezzo di tali possibilità, aspettando qualcosa che non arriverà o tarderà, infine.