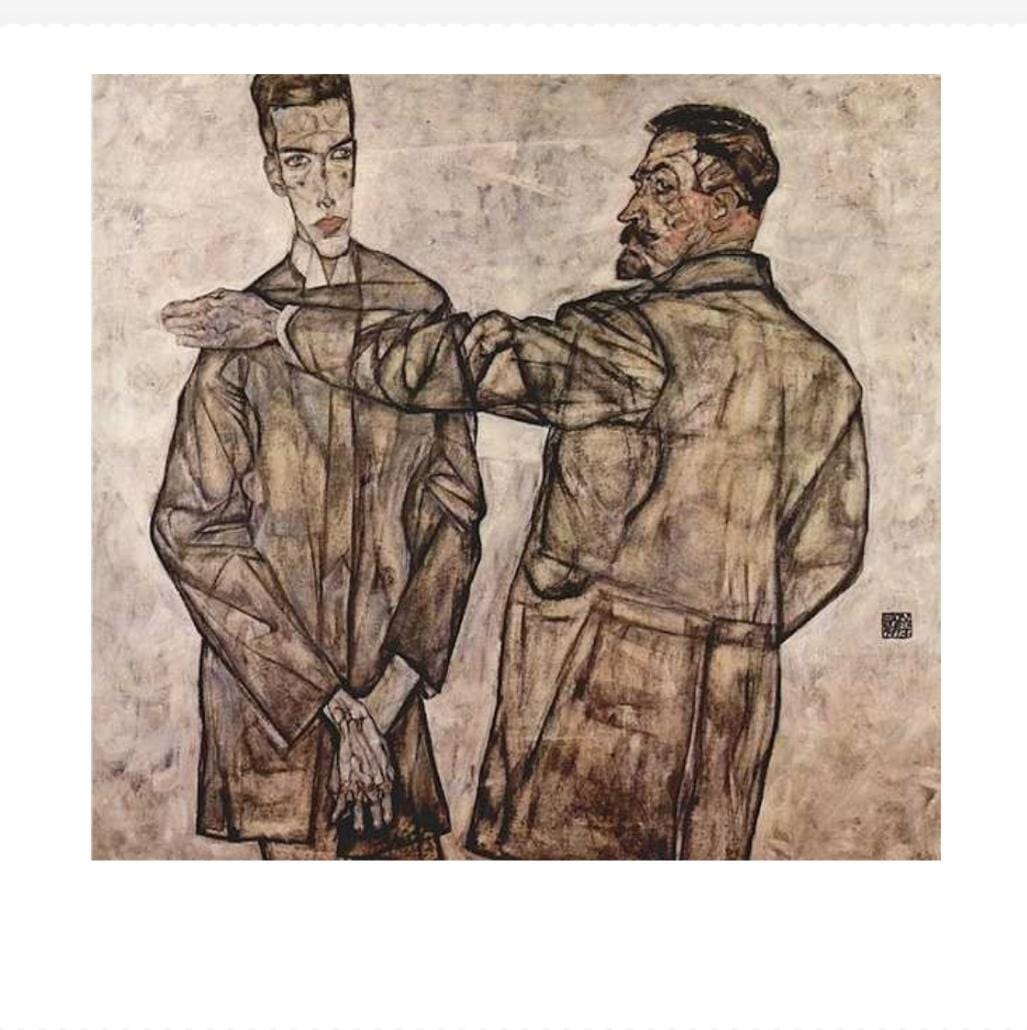di Demetrio Paolin
PADRE/FIGLIO. «Un padre […] è un male necessario» [IX, 324], il capitolo IX dell’Ulisse ha luogo nel chiuso della biblioteca; unico, quasi unico se si escludono delle brevi apparizioni di Bloom, protagonista è Stephen che in queste pagine racconta e mette in scena una grande, traboccante e in parte sconclusionata teoria sull’Amleto di Shakespeare, sulla paternità e sull’essere figli; una riflessione che in parte aveva già affrontato nel corso nel capitolo III, ma che in quel caso si era completamente risolta in un lungo monologo/soliloquio «la voce del mio padre consustanziale» [III, 78]; in queste pagine invece Stephen è protagonista di un dialogo, dalle movenze platoniche, denso, complesso, contraddittorio, scambi di battute, facezie e arguzie che producono con l’addentrarsi della discussione una vera e propria metamorfosi strutturale. Infatti, parlando di Shakespeare e delle sue opere, il testo si trasforma una pièce teatrale [IX, 327-328]. Il tema di queste pagine sta nel tentativo di definire con una certa precisione il rapporto tra padre e figlio come rapporto di identità: «Cosa significa un nome? È ciò che ci chiediamo nell’infanzia quando scriviamo quello che ci vien detto essere il nostro» [IX, 328].
Per sviluppare questo tema, che è appunto una ripresa della riflessione che aveva dominato la prima parte (i primi tre capitoli, quelli che potremmo definire una sorta di Telemachia, dove appunto c’è un figlio in cerca di un padre), Stephen apre una lunga discussione che verte sull’Amleto e su come e in che modo questa opera possa illuminarci sulla vita di Shakespeare. L’ipotesi suggestiva di Stephen consta in un ribaltamento di prospettiva. Shakespeare quando scrive l’Amleto, non immagina se stesso come Amleto, ma immagina lui di essere Amleto padre morto, e immagina che Amneto-figlio morto sia Amleto, il figlio, vivo. «È possibile che quel Shakespeare attore, spettro per assenza e, in veste di sepolto signore di Danimarca, spettro per morte, rivolgendo le proprie parole al nome del suo stesso voglio (se Amneto Shakespeare fosse sopravvissuto sarebbe stato il gemello del principe Amleto), è possibile, chiedo, o probabile che non abbia tratto o previsto la conclusione logica di quelle premesse: tu sei il figlio spossessato, io sono il padre assassinato, tua male è la regina colpevole, Ann Shakespeare, nata Hathaway» [IX, 295]. Notiamo per prima cosa come questa esposizione della trama della Amleto sia così simile alla linea narrativa di Bloom: un uomo che vive una sorta di esistenza purgatoriale, un uomo che è orfano del proprio figlio, e una donna che lo tradisce. Joyce ci vuole forse suggerirci come nell’Ulisse, la centralità dell’Amleto vada oltre il semplice citazionismo (nel capitolo IX le citazioni della tragedia sono moltissime), ma appunto riguardi in qualche modo un “nodo” più profondo. Non ci si inganna nel vedere come questo movimento a triade descritto da Stephen riprenda in parte la storia dell’Odissea. Soggiace in questa storia, quindi, una sorta di continua richiesta di senso, che si dà prima di tutto nell’identità, ma lì non si conclude.
Nell’immaginario di Stephen, Shakespeare è «una miriade di menti» [IX, 321], è l’artista che «tesse e disfa la propria immagine» [IX, 304], che «attraverso lo spettro dell’inquieto padre guarda a noi l’immagine del non vivente figlio» [IX, 305]. Tramite l’analisi dell’Amleto, compiuta da Stephen, Joyce arriva a toccare una vertigine speculativa, che fa di questo dialogo che stiamo leggendo una riflessione altissima, degna di un dialogo platonico, e che iscrive l’Ulisse tra i grandi romanzi-saggio del nostro primo ‘900 (penso a La Montagna Incantata, a L’Uomo senza qualità), cioè narrazioni in cui il dato speculativo, di riflessione filosofica, è il motore reale dell’azione drammatica.
L’immaginazione «è un carbone che si va spegnendo, ciò che io ero è ciò che io sono e ciò che in potenza potrei divenire. Così nel futuro, che è fratello del passato, potrò vedermi mentre siedo qui adesso soltanto per un riflesso di ciò che sarò allora». [ivi]
Il tema del tempo e il tema dell’identità/diversità tra padre e figlio spinge le riflessioni di Dedalus a riprendere il filo delle eresie sulla trinità, che come ricordiamo era una delle tematiche centrali della prima parte. Stephen ricorda un eresia in cui si sostiene che «il Padre è Egli stesso il Proprio figlio» [IX, 325], ma questa visione possiede una fallacia logica che Dedalus smaschera citando San Tommaso: «se il padre che non ha un figlio è un padre, può essere figlio il figlio che non ha un padre?» [ivi]. Questa interrogazione retorica produce il ragionamento finale di Stephen, ovvero quando Shakespeare «ha scritto l’Amleto non era solamente il padre del proprio figlio ma, non essendo più un figlio, era e si sentiva padre di tutta la stirpe, il padre del suo stesso nonno, il padre del suo nascituro nipote…» [IX, 326]; alla luce di queste parole diventa chiaro perché è centrale interrogarsi sullo scrivere il nome che ci dicono essere il nostro [IX, 327] che riprende la domanda che Bloom si poneva nel capitolo ottavo: «Sono così, io? » [VIII, 265].
Della frase di Bloom evidenzio (in grassetto) lo statuto identitario: la frase potremmo leggerla anche in questo modo “io sono così {come voi siete}?” che rende esplicita l’identità, che si riverbera nel nome, che però ci dicono essere il nostro. Il nome è una convenzione, è esterno alla cosa che nomina, la definisce per assenza, la definisce per ciò che non è. Un figlio è tale quando smette di essere figlio, e diventa padre di suo padre, accudendolo o prendendosene cura nella vecchia, ma se il figlio diventa il padre di suo padre, linguisticamente diventa suo nonno. La mia identità si definisce non per ciò che sono, ma quando mi privo di ciò che sono, ovvero avviene per privazione: io so il-essere-figlio, quando non lo sono più o sono costretto a non esserlo più, io sono padre nel momento in cui mi viene estromessa la possibilità di esserlo: l’orfanità, che avevamo visto essere uno dei temi dominanti dei primi capitoli, altro non è che questa privazione – il “no-one” che ci definisce per negazione (vd. Appunto 4) –¸ il renderci poveri stabilisce i confini di ciò che siamo; quindi ciò che sembra impossibile o fallace, per il buon senso comune “posso essere io il nonno di mio padre?” – diventa possibile nel linguaggio (questo flusso costante che domina tutto il romanzo), che appunto si configura come un’avventura, un perdersi nel mare aperto – siamo all’altezza di Scilla e Cariddi nei supposti paralleli tra Odissea e Ulisse – ed è qui che si liberano in vortici speculativi abissali: chiedersi cosa è padre e cosa è figlio, anzi cosa è Padre e cosa è Figlio, quale sia il loro rapporto diventa nel discorso di Stephen chiedersi cosa è a realtà, e osservare il mondo «come capita di vedere nella vita reale» [IX, 284] .
IL REALE/LA COSA. Il reale è il cosa è [IX, 391]. La citazione per esteso è: «La cavallinità è il cosa è di tutti i cavalli» [ivi]. Cosa-è traduce quello che in latino potremmo chiamare quidditas. Terrinoni traduce la stessa frase con “La cavallinità è l’essenza del cavallo universale” [Terrinoni, 200], Celati scrive: “La cavallinità è la quiddità di tutti i cavalli” [Celati, 256]. Nell’originale leggiamo: “Horseness is the whatness of allhorse”: quindi il termine quidditas non è presente nel testo di Joyce, che usa un vocabolo che suona come “che cosa”; in questa occasione trovo centrata la scelta di Biondi, perché tiene conto e della lettera del testo e dell’ambiguità del termine “cosa”. Nei diversi appunti fin qui scritti abbiamo spesso ragionato in maniera disordinata sulla tensione realistica di Joyce, in appunto 3 abbiamo citato Pound, il quale sosteneva che Joyce fosse un realista, perché dà la cosa come essa è. In quella occasione si è discusso e ragionato sul realismo di Joyce, il tema dello specchio che rappresenta la vita e il fatto che la superficie riflettente, se dobbiamo continuare in questa metafora, dell’Ulisse è quanto meno sbrecciata e fessa. La domanda, che ci possiamo porre all’altezza di questo capitolo, e anche vista l’armamentario retorico e filosofico che Joyce usa durante questo dialogo, è: “Joyce è più interessato alle realtà o al reale?”.
La domanda non deve parere peregrina: c’è una profonda differenza tra reale e realtà, la stessa che esiste tra whatness e qudditas. Se volessimo giocare a fare gli scolastici medioevali potremmo scrivere in questo modo la frase sui cavalli: “La realtà è la quidditas del reale” o meglio ancora “La realtà è il cosa è del reale”. Cosa significa questo? Significa che ciò che noi chiamiamo realtà, ciò che noi descriviamo ogni giorno, è solo un attributo del reale, ma non è il reale stesso, ciò che noi sappiamo del reale è che in dato momento e in dato luogo diventa realtà, ma il “cosa è”, quello che c’è prima e che sta sotto, che presuppone la realtà (realtà = attributo del reale), ci sfugge.
Questa sfuggevole tensione, alcune volte tortuosa e altre così cavillosa, che produce scherno e derisione dal buon senso comune (la maggior parte degli interlocutori di Stephen pensano che sia pazzo o si annoiano), è il cuore del romanzo, nonché il cuore della riflessione joyciana sulla letteratura (nei vari schemi e diagrammi il capitolo IX si muove sotto l’egida della letteratura); il compito dello scrittore è quello di mostrare questo spazio tra reale e realtà, mostrare, come accade nei momenti di semiveglia – la famosa veglia di Finnegans e il suo linguaggio nascono qui? -, che oltre la realtà esista qualcosa di più profondo e sconosciuto: il cosa-è.
Il reale si dà non per “addizione” – le qualità delle “cose” non sono altro che specificazioni che allontanano la “cosa in sé”? Pensate per un attimo a questa frase: “Dio è onnipotente, immenso, onnipresente, buono, infinito, etc etc”; tutti gli aggettivi e le specificazioni servono a eludere la questione essenziale ovvero “Dio è?” -, ma si raggiunge per negazione. Il reale esiste nel momento in cui dietro il realtà appare qualcosa che intravediamo, come fosse uno scambio o un miraggio: la realtà sono i mulini a vento, il reale sono i giganti.
È il vecchio tema della discrasia tra le parole e le cose, tema che Foucault ravvede per la prima volta nella letteratura in Don Chisciotte. Non stupisce, quindi, date queste premesse, che il personaggio di Cervantes compaia nell’Ulisse: «Un cavaliere dalla trista figura qui a Dublino» (IX, 302). Stephen, Bloom e Chisciotte hanno lo stesso intento narrativo, mostrano a chi legge che il compito della letteratura non è la descrizione della realtà, ma l’indagine sul reale: sul “cosa-è”, che sempre fugge, sempre ritorna, come una melodia, come un suono, come le sirene che troveremo nel capitolo XI.