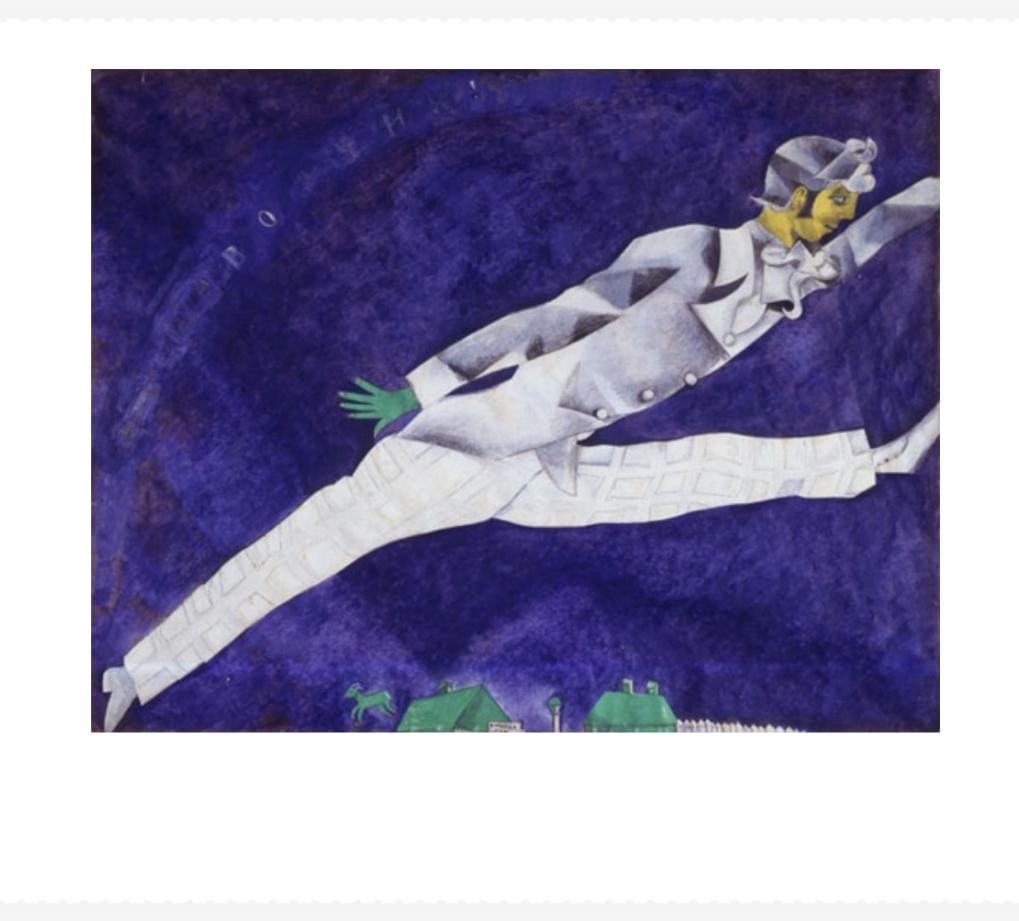di Demetrio Paolin
- «Per parlare con franchezza qui tra noi» (TdN 3) è questo l’incipit della Trilogia: la mia attenzione si posa sul verbo parlare, che si configura come un sinonimo di scrivere. Per Céline scrivere è parlare, parlare sostituisce nel modus operandi della composizione della trilogia lo scrivere (Céline prova orrore per lo scrivere TdN 91: «… ho sempre trovato indecente, solo anche la parola: “scrivere”!»). «Vi parlo di mia madre» (TdN 6); «Io mi scuso di parlare tanto di me stesso» (TdN 17); «vi parlo di Achille» (TdN 41); l’idea dell’oralità – di questa finzione dell’oralità, perché la prosa céliniana è assolutamente ordinata, retoricamente impostata – è nella realtà il risultato di un sapiente ordito; si prenda per esempio questa sequela di aggettivi «lustro, pettinato, pitturato e laccato» ( TdN 3) che dovrebbero descrivere il dottor Céline come dovrebbe essere e la si confronti – poche righe dopo – con il ritratto di come è: «Scorbutico, sdentato, ignorante, scaracchioso, gobboso» (ibidem). C’è una simmetria e un equilibrio, oltre a una profonda ironia, che ci fa comprendere come questo parlato non sia una semplice registrazione neutra di un discorso orale, ma si configuri come una orazione, quindi come abbia a che fare con la retorica e, quindi, con l’organizzazione del discorso. Discorso/ordito: Céline parla del suo cappotto, la cui stoffa ha resistito a 14 anni di avventure, e così lo descrive – «Il mio è qui! Logoro senza dubbio” d’accordo! Alla trama!, 14 anni di peripezie! Alla trama!» ( TdN 6) –, creando subito un rapporto tra la trama del cappotto e quella del suo romanzo.
Continuando ad analizzare l’inizio di Da un castello all’altro mi soffermo sul termine “qui”. Cosa indica questa particella di luogo? Individua il luogo e il tempo presente del racconto, Céline porta il lettore nella sua casa nel suo sobborgo alle porte di Parigi. Ci porta momento presente, in cui scrive le pagine come se parlasse. Questa sensazione è rafforzata dal “tra noi”, come se costruisse una sorta di assemblea e un luogo esatto dove noi, da intendersi lui che parla/scrive/declama e i lettori che ascoltano, siamo.
5.1 A latere di questa postilla sull’incipit di Da un castello all’altro, mi segno una piccola notazione. Nell’Iliade il poeta chiede alla Musa di cantare l’ira funesta etc etc; nell’Odissea il poeta chiede alla Musa di parlargli dell’uomo etc etc: non credo che sia una differenza di poco conto; cantare e parlare non indicano il medesimo gesto, parola e canto non sono la stessa cosa. Il romanzo deriva dal canto o dalla parola? Chiaro che io propenda per la seconda, mi pare interessante che pure Dio dovendo scegliere in che forma presentarsi abbia prediletto il “verbo” e non il “canto”: si potrebbe ragionare in questo modo per una genealogia del romanzo?
- Il lettore infatti viene più volte chiamato in causa nel corso della narrazione, il suo ruolo è attivo, anzi mi verrebbe da dire che Céline pensa ad un lettore ostile, spesso distratto, incline alla noia e a perdersi negli andirivieni delle pagine della Trilogia. L’apostrofe al lettore rappresenta una sorta di “ricalibratura” del racconto, come se il lettore fungesse da richiamo all’ordine del racconto: la sua funzione non è tanto quella di ascoltare/leggere, quanto quella di richiamare Céline ai suoi doveri narrativi. «Mi attardo… vi infastidisco forse?… vi parlavo di Madame Nicois» (TdN 58) in questa citazione vediamo appunto:
a)il perdere tempo – cosa è la digressione narrativa se non un modo per fermare il tempo della lettura, rispetto alla linea narrativa principale, uno stallo;
b)l’ostilità e il fastidio del lettore;
c) la sinonima parlare/scrivere.
«Lasciamo il passato al Grevin!… Al presente! a Madame Nicois!… stiamo a casa sua» (TdN 61); «Accidenti!… divago… vado a perdervi!» (TdN 65); «Ecco qui!.. ecco qui!… folleggio! Miro all’effetto! Vado a perdevi…» (TdN 89) e potrei continuare che molte sono presenti di queste invocazioni, chiamate in causa al lettore ( TdN 134; 139; 170; 191). Nella loro quasi totalità, però, oltre a essere uno strumento retorico per chiamare il lettore in causa, servono sempre per riportare e rimettere in sesto il tempo della narrazione e il luogo della narrazione.
In Trilogia il tempo della narrazione e il tempo dei fatti tendono a confondersi; il personaggio che dice Io nel romanzo ha la capacità di muoversi indifferente nel passato, nel presente e nel futuro (in Da un castello all’altro l’uso prolessi è ampio, vd prossime postille), i richiami al lettore sono come una sorta di paletto in cui l’autore torna al tempo di ciò che sta narrando. Quando questi avvengono nella prima parte dei romanzi, nei quali a dominare è il tempo presente della scrittura – l’oggi in cui Céline scrive -, questi appelli suonano come un richiamo a non divagare, a non anticipare troppo, quando invece avvengono mentre l’Io narrante sta raccontando il dato storico, le apostrofi pongono solitamente fine o una incursione nell’oggi della scrittura o per concludere una possibile anticipazione di ciò che sarà.
- La più banale delle notazioni: Céline non vuole scrivere un romanzo tradizionale. C’è un qualcosa che, però, non torna in questa affermazione perché egli utilizza molte delle micro-strutture romanzesche. Ad esempio quando per descrivere le sue vicende le definisce peripezie ( TdN 30); ci possono essere diverse definizioni di peripezia, ma a me pare interessante quella di Kermode, «La peripezia, […], è presente in ogni racconto che abbia un minimo di congegno strutturale» (Il senso della fine, p.23), perché sottintende che essa sia una struttura del romanzo e di certo Céline non usa questo termine a caso: Da un castello all’altro, ad esempio, possiede una sua struttura, una sua circolarità (il luogo di inizio e di fine del romanzo coincidono, il personaggio di Madame Nicois che aveva segnato l’avvio del delirio febbrile e il racconto segna con il suo riapparire anche la fine dello stesso).
Céline abbiamo notato instaura un dialogo costante e continuo con il lettore, utilizzando – alla maniera di Hugo e Balzac – la prolessi non tanto come moderno spoiler ma come tentativo di imporre una diversa suspense. C’è in queste scelte che tornano più volte il fantasma del vecchio romanzo dell’ottocento, il costruire una trama che ogni tanto si fermi – «Sono pieno di digressioni» (TdN 230), che anticipi qualcosa di ciò che avverrà – «abbiamo conosciuto molto peggio… Korsor là in alto! Baltavia, il Belt!… e quando a ghiaccio, vi racconterò… ma qui, è già mica male!… mica d’andare a spasso» (TdN 66) – per fare in modo che il lettore desideri andare avanti. Nell’ultima citazione Céline si riferisce a qualcosa che verrà narrato molto dopo, nel finale della trilogia ovvero nella pagine di Rigodon: faccio notare come nuovamente il lettore – vi – serva da richiamo, da paletto retorico per non andare troppo avanti con la storia con la particella di luogo “ma qui”. - Altra notazione in sé banale. Ciò che colpisce nella lettura della Trilogia è l’uso della punteggiatura e in particolare dai puntini di sospensione. Céline ne parla a lungo in vari testi e interviste che non mi pare quasi il caso di discuterne, basti citare qui Colloqui con il professor Y, nel quale appunto Céline intervista sé stesso e parla dei suoi “indispensabili” tre puntini. Mi sono reso conto che, però, la mia attenzione riguarda un altro segno di interpunzione: il punto esclamativo. Non ho fatto una ricerca approfondita e numerica, ma ho l’impressione che il segno di esclamazione sia utilizzato dallo scrittore francese quasi alla pari che il segno di sospensione. L’interpunzione, lungi dall’essere – almeno nei romanzi – un mero marcatore del ritmo della lettura, si è trasformato nel tempo, quando la lettura delle opere è passata da essere pratica condivisa di lettura ad alta voce a pratica silenziosa solitaria, in uno strumento di contenuto. In questo senso basterebbe dare uno sguardo alla storia del romanzo, penso a quello settecentesco inglese, per vedere come i romanzieri di quel periodo debbano immaginare nuovi segni grafici, oltre ai soliti usati per convezione, per produrre o riprodurre nuove fasi della lettura (cfr Rosamaria Lorentelli, L’invenzione del romanzo, Laterza).
Céline non è da meno nel suo lavoro di rimaneggiamento della punteggiatura. Perché mi colpiscono o, meglio, attirano la mia attenzione i punti esclamativi? Perché anche in questo caso sono una microstruttura del romanzo ottocentesco; meglio, sono ai miei occhi una sorta di sineddoche strutturale di quel tipo romanzo. Se prendiamo un autore come Hugo, registriamo come nel descrivere i sentimenti dei propri personaggi utilizzi una sorta di enfasi, di grandezza, di enormità: Quasimodo, Jean Valjean spesso dichiarano le loro emozioni con un furore che potrebbe essere rappresentato come una esclamazione. Sembrerebbe quasi che loro stessi siano i primi a stupirsi di ciò che sentono. È questa una cosa che si avverte ad esempio anche in certi passaggi, non tutti, di Balzac, penso a Splendori e miserie delle cortigiane quando Jacques Collins viene a sapere la morte di Lucien de Rubempré: è un momento altamente drammatico, in cui veniamo a sapere i “reali” e più “profondi” sentimenti di questo personaggio nei confronti del suo protetto.
L’esposizione dei sentimenti in modalità esclamativa (mi si perdoni questa esposizione fin troppo semplificata, ma queste sono appunto solo postille di uno che legge un libro e prende qualche appunto di corsa) viene via sostituita dal concetto di interiorità: lentamente essa diventa una sorta fiume che scorre nelle pagine e non ha veri e propri fiotti o esplosioni o scoppi. Joyce, Proust la Woolf producono una prosa in cui il “dentro” degli esseri umani è mostrato fin nelle minime sfumature, e quindi non ha bisogno dell’esclamazione, ma della virgola o della sua completa assenza, ma sempre all’interno di una frase complessa tornita e strutturata (il flusso monologante di Molly lungi dall’essere senza filtri ha invece una precisa grammatica espositiva e un suo ritmo di lettura). Questo tipo di modello di descrizione non è seguito da Céline, che ha intrapreso una sua battaglia, di amore e odio, nei confronti di Proust (vd Magrelli, Proust e Céline, Einaudi) e che ad esempio, in un passo de Da un castello all’altro, utilizza il verbo «prousteggiare» ( TdN 99) con evidente riferimento a un certo tipo di narrativa che lui non ama, perché per lui invece «le emozioni bollono, ribollono, portano via tutto!» ( TdN 215). Céline, quindi, per opporsi a Proust ritorna indietro all’Ottocento, lui stesso si definisce un uomo dell’altro secolo «ripeto la mia età… 1894!… farnetico?… biascico?… ci ho il diritto!.. tutte le persone che sono dell’altro secolo hanno il diritto di farneticare!» ( TdN 7). Chiaramente Céline non riprende quello che era il romanzo ottocentesco e lo ripropone: non sarebbe stato né sensato né nella sua indole. Se Joyce nell’Ulisse ha tentato di riprodurre un mondo complesso, variopinto e stravagante e lo ha tenuto insieme, paradossalmente, con la vecchia forma del romanzo, costruendo una sorta di museo dello stesso, così Céline si muove in quello stesso luogo ma dopo la deflagrazione di una bomba: egli cammina tra muri diroccati che dicono quasi più nulla, e in questa rovina egli trova alcuni rimasugli, qualcuno potrebbe chiamarli topoi retorici, stilistici, concettuali, e con questi tira il suo romanzo di rovine. - L’ultima citazione ci conduce, è solo prima di altre postille sull’argomento, al tema dello stile; c’è nelle pagine della Trilogia una frenesia, un biascicare (quasi le parole si legassero le une alle altre come come in un impercettibile sussurro) e una sorta di farneticazione: «Io vi racconto tutto così come viene… secondo le scosse, cigoli della lettiera… che so più quello che mi scuote… la febbre?… la rete che cede?…» (TdN 111). Questo farneticare avviene «nel momento che tutto crolla, capitombola!… rottura totale!» (TdN 121). Questo modo di esprimere la sua scrittura ha a che fare con lo choc, delle due guerre. Céline, nel riferirsi al fatto di essere un uomo del secolo scorso, ammette di non avere gli strumenti per comprendere ciò che è accaduto e di cui è stato inconsapevole testimone; c’è uno choc percettivo che è perfettamente tratteggiato da Benjamin nel suo saggio su Leskov: «Una generazione che era ancora andata a scuola con il tram a cavalli, si ritrova sotto il cielo aperto, in un paesaggio in cui nulla era rimasto immutato fuorché le nuvole, e sotto di esse, in un campo magnetico di correnti e esplosioni micidiali, il minuto e fragile corpo dell’uomo».
Céline appartiene alla generazione ritratta in queste righe e ha la fortuna o la sfortuna di vivere sia il terribile rivolgimento della prima guerra e di seguito ciò che accade nella seconda. Se la Prima Guerra aveva come aperto la breccia in cui questo choc percettivo pareva infilarsi è stato con il secondo conflitto mondiale che tale breccia salta ed esplode tutto. A fare le spese di questo stravolgimento storico, sociale, antropologico è lo strumento del romanzo: se ancora Joyce o Proust potevano avere fiducia in questa struttura narrativa, dopo il ‘45 tutto questo viene meno. Alla luce di tutto questo non è imputabile alla casualità il fatto che Benjamin – uno dei più profondi critici letterari del primo ‘900 – non dedichi mai molto spazio nella sua speculazione al romanzo (un unico esempio eclatante sono le Affinità Elettive) e che la sua opera letteraria, speculativa e più profondamente innovativa sia un testo pensato per non essere mai concluso e dall’impianto frammentario come I “passages” di Parigi. E d’altronde è curioso che proprio i passages, che il filosofo tedesco vede come il luogo in cui la modernità entra e si fa vedere, siano anche il luogo della prima infanzia di Céline?
C’è, quindi, nel periodare céliniano, nel suo sobbalzare, nella furia e nel biascicare le parole di certo l’eco delle esplosioni delle bombe, della deflagrazione, ma c’è anche l’attestazione di una debolezza e dell’impossibilità di riportare tutto all’unità, all’uno, all’insieme: lo scrittore deve accontentarsi di mettere insieme pezzi, senza neppure più il paziente lavoro di puntello, ma di giustapporli e sperare che si tengano: «La testa è una specie di officina che funziona mica così bene come uno vuole… pensare! Duemila miliardi di neuroni completamente in pieno mistero… stai fresco! […]hai vergogna… […] ma non so più… ritrovo più!… vi ritroverò!… voi e il mio Castello… e la mia testa! […] mi ricordo una parola! […] ritrovo il filo! […] ah, rieccomici!» (TdN 112).