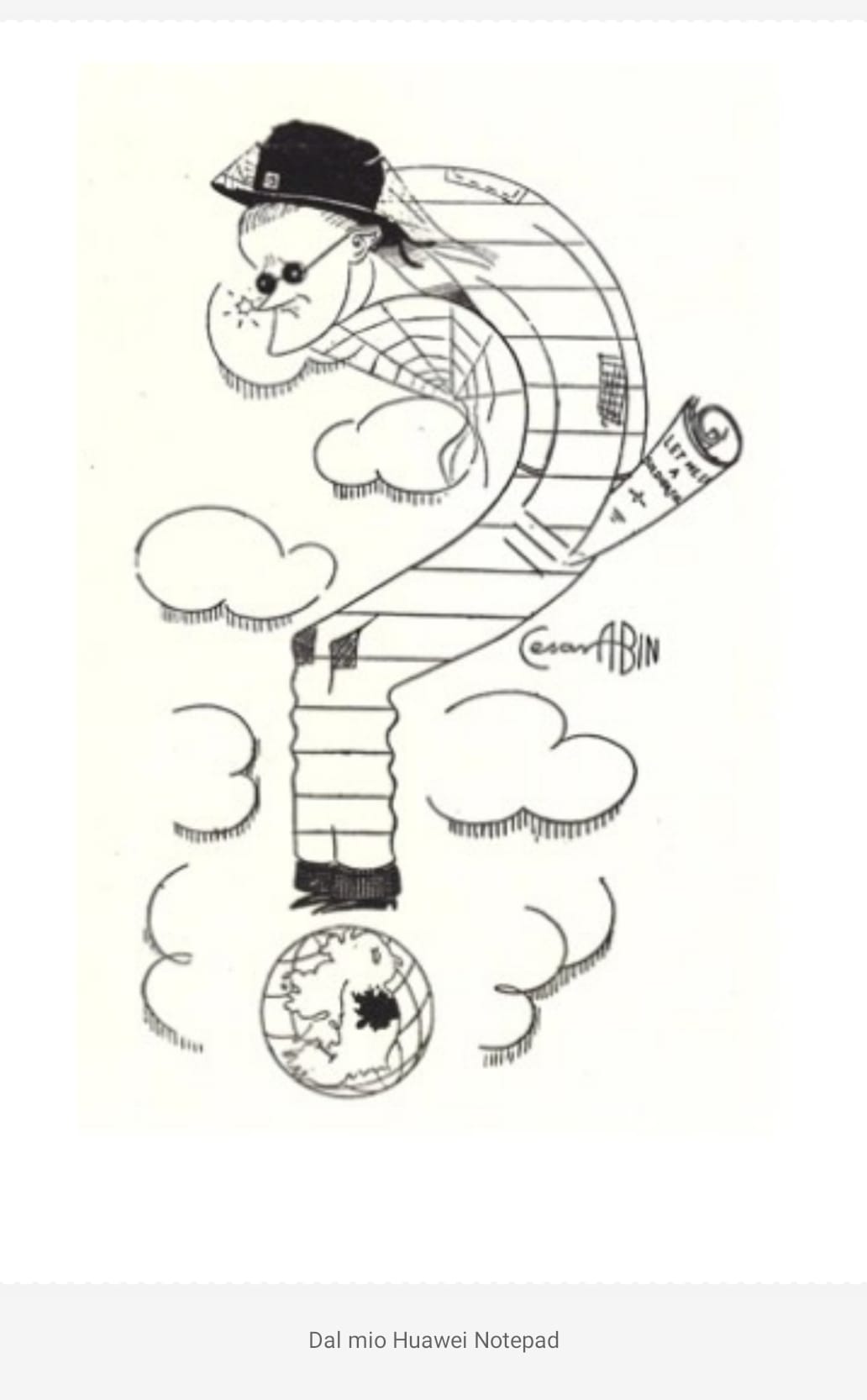di Demetrio Paolin
BUCK. Dell’incipit del romanzo, o meglio del periodo che apre il romanzo, sottolineo il soggetto e le sue apposizioni: «Statuario, pingue, Buck Mulligan» [I, 21]. Cosa si vede? In primo luogo la mescolanza di alto e basso, non tanto nel registro linguistico, quanto concettuale: “statuario” ci porta alla mente i monumenti; mentre “pingue” afferisce certo all’obesità,ma è connotato dal suo riferimento a Falstaff, il personaggio scespiriano definito più volte nelle sue apparizioni come “pingue”. Sono sufficienti, quindi, poche parole per capire già quale sarà il linguaggio dell’Ulisse: alternanza di registro alto e basso, marcata inter-testualità. Proseguendo nella lettura, troviamo lo “specchio” e il “rasoio”, due oggetti neutri in sé, ma il loro posizionamento a croce e la successiva citazione latina dal salmo attirano la nostra attenzione. Buck è un sacerdote che celebra una messa o un surrogato di essa. L’intento parodico (non in senso spregiativo) dell’Ulisse, quindi, è sin dalle prime righe decisivo: la natura dei grandi romanzi è di presentarsi come antimodello.
STEPHEN. Quindi (clausola temporale) appare Stephen Dedalus: la sua descrizione non è incentrata sul corpo (vd. Buck), ma sul suo nomignolo: Kinch. La parola allude al termine bambino, ma assonante nel significante al rasoio affilato. Stephen, perciò, lo abbiamo già incontrato, senza riconoscerlo, nel rasoio delle prime righe, accompagnato dallo specchio. Specchio che ritorna [I, 30] nel momento in cui Stephen si domanda: «Come mi vedono lui e gli altri? Chi mi ha scelto questa faccia?». Tale interrogativo potremmo rubricarlo sotto il tema del discorso dell’orfano: Stephen ritorna sul tema della madre, della sua morte e sul tema del padre, che è presente come ragionamento letterario: il dialogo e le riflessioni su Amleto [I, 47-48], ma anche all’elenco delle diverse eresie [I,51], che hanno appunto come loro centro il rapporto tra Padre e figlio; mentre nel capitolo III la figura del padre si incarna nella voce «consustanziale» [III, 78], che si mescola con il flusso di pensieri diretti di Dedalus. Questo tema è il primo punto di contatto tra Ulisse e Odissea, molto più che le corrispondenze architettura narrativa o le citazioni dei calchi omerici; infatti nell’Odissea il viaggio ha a che fare con l’identità. Ulisse, declinando il suo nome come nessuno, non mette solo in atto uno stratagemma furbesco, ma attribuisce a sé stesso una condizione umana monca: Ulisse è letteralmente nessuno, uomo da nulla, è stato re marito guerriero, ma mentre fugge da Polifemo, non è più nulla. Telemaco, nel parallelo istituito da Omero, vive la stessa condizione del padre, non più figlio, non più figlio di re, non più pretendente al trono, si trova nella stessa situazione del padre: non è nessuno. A questo viaggio come movimento esteriore che produce cambiamenti interiori si può collegare il susseguirsi delle azioni e dei gesti nelle prime pagine del romanzo, nelle quali è ravvisabile una sorta di dicotomia tra dentro e fuori. Se ripercorriamo i gesti dei personaggi noteremo che a) Buck e Stephen sono sulla torre (fuori), b) poi entrano dentro una stanza (dentro), c) escono (fuori), d) quindi Buck si immerge nel mare (dentro); e) Stephen è in classe (dentro), f) poi i suoi ragazzi escono per giocare (fuori), g) poi lui entra dal preside Deasy (dentro), h) quindi esce per andare dallo zio (fuori) e i) infine è a casa dello zio (dentro). Questo continuo dentro/fuori, che è spaziale, ha una declinazione fisica in Stephen, anzi nella parole che Buck dedica a lui: «Il moccichino del bardo. Un nuovo colore per i nostri poeti irlandesi: verde moccio» [I, 28]. Il moccio esce dall’intimo di Stephen: è segno preciso dell’interiorità del protagonista. È sintomo di qualcosa di marcio, che egli ha dentro di sé: in questo verdastro, che ricorda la tonalità di certi incubi di Shakespeare, pieni di acqua putrida e torbida, non c’è nulla di salutare. Ecco l’identità di Stephen è una identità di colpa come gli ricorda Buck: «La zia pensa che sei stato tu a uccidere tua madre» [I, 29]. In queste prime pagine il tema della morte della madre si presenta spesso [ I, 30-31; II, 61], ma mi soffermo su un episodio del capitolo II , Stephen pone un antico un indovinello ai suoi alunni: «Cantava il galletto/il cielo era perfetto: del paradiso i batacchi/battevano undici rintocchi./ È ora che quest’anima buona/vada in paradiso.// Cos’è?» [II, 59]. Mi soffermo su quest’ultimo stralcio di testo, perché appunto l’indovinello è un’interrogazione profonda sull’identità. Nei versi possiamo individuare una serie di echi evangelici, il canto del gallo/tradimento, “è ora”/consumatum est dal vangelo di Giovanni, le ore battute/le tre del pomeriggio orario della morte di Cristo. Siamo davanti a una piccola passione, al racconto di una morte e di un tradimento. A pronunciare questo indovinello è Stephen che come abbiamo visto è accusato di aver “ucciso” la madre. Reso più esplicito l’indovinello, anche la risposta allo stesso deve essere interpretata. Dopo alcuni tentativi a vuoto dei suoi alunni, ecco la risposta alla domanda: «La volpe che seppellisce la nonna sotto un cespuglio di agrifoglio» (II, 59). Rispetto alla risposta tradizionale, Stephen non usa il termine “madre”, ma “nonna”: una sostituzione, un breve scarto, un lapsus, che mostra chiaramente la sua colpevolezza.
MADRE/MARE/ESILIO. L’immaginario legato alla madre non si conclude qui. Joyce gioca una serie di rimandi narrativi, di tessiture di vocaboli, che in un certo senso legano il tema del mare e a quello della madre. Buck stabilisce un rapporto tra mare e verde moccio tramite il calco omerico de «Il mare color verde moccio» [I, 28], poche righe prima Buck ha dichiarato che il mare è «una dolce e grande madre» [I, 28], e successivamente con una piccola variatio sostiene che l’acqua è «la nostra potente madre». La trasformazione del mare nella madre e il successivo legame con la colpa di Stephen avviene poche righe più sotto: «Attraverso l’orlo liso del polsino vedeva il mare salutato nei termini di grande dolce madre dalla ben pasciuta voce al suo fianco. L’anello di baia e orizzonte racchiudeva un’opaca massa di liquido verde» [I, 29]. Il mare verde suggerisce anche la madre patria. Anche in caso Joyce gioca con una serie di rimandi, che infine legano il mare al latte, bevuto durante la colazione [I, 39-41]. A tenere insieme è l’apparizione di una vecchia, osservata tramite gli occhi di Stephen: «La guardò versare nel misurino e da lì nel bricco sostanzioso latte bianco, non suo. Vecchie poppe vizze. Ne versò di nuovo una misura […] strega seduta sul suo fungo velenoso, le rugose dita svelte sui capezzoli spruzzanti. Muggivano intorno a lei, che conoscevano, animali serici di rugiada. Seta di vacca e povera vecchia, come chiamavano un tempo l’Irlanda. Una vecchia errante» [I, 41]. Queste parole possono essere lette in parallelo con quelle [II, 61] in cui Stephen racconta di come sua madre «con il suo sangue debole e il latte acido di siero lo aveva nutrito e aveva celato alla vista degli altri le sue fasce». Il tema della madre patria che nutre da tette vizze simboleggia l’esilio, che viene introdotto da alcuni riferimenti al cibo e al denaro che si coagulano in una serie di riflessione sulla condizione ebraica (di per sé esiliata). Nel cap. II assistiamo al colloquio tra Stephen e il preside Deasy che all’atto di pagare Dedalus per il suo lavoro di insegnante, dà il via una lunga tirata, dove sono ripresi molti dei temi tipici contra judaeos: «Hanno peccato contro la luce. E gli si vede il buio negli occhi. Ed è per questo che vanno tuttora errando sulla terra» [II, 69]. Poche pagine prima [II, 58] Stephen si paragona a un essere che non sopporta la luce: «[…] sotto lampade di luminescenza, impalati, con antenne che fremevano lievemente; e nel buio della mia mente un bradipo da inferi, riluttante, schivo della luce, che muoveva le sue scagliose spire di drago. Pensiero è pensiero del pensiero. Luce tranquilla». Si può ipotizzare una sorta di sovrapposizione sulla condizione dell’erranza ebraica e la propensione alle tenebre, secondo le parole del preside Deasy, e la condizione all’esilio e al buio di Stephen Dedalus, che infatti afferma: «Io non vedo niente»[II, 58]. Il tema dell’ebreo errante e l’erraticità saranno fondamentali nello sviluppo del romanzo, ma già qui se ne avvedono i prodromi.
PARANOIA. «Guarda. Sempre lì senza te: e sempre, nei secoli dei secoli» [III, 76]. Nel capitolo III si incontra questa affermazione, che pare alludere alla reale. Esiste una realtà che è inaccessibile, che sta “lì senza di te” e da sempre, sono le cose reali e concrete; gli alberi, la malattia, il cibo, lo sperma, la gioia, i pensieri, il sesso e la morte sono cose che sfuggono a una concreta comprensione. C’è un albero qui davanti alla mia finestra: posso dire una serie di cose su questo albero, come è cresciuto, quando ha messo le gemme, quando ha messo le foglie etc etc; ma come posso conoscere quello che l’albero è? Posso solo immaginare quello che l’albero è, posso solo dire cosa è in relazione a me: la realtà che io descrivo è soltanto in relazione a me soggetto che la guardo, non ne ho esperienza. Potremmo definirla una sorta di paranoia, perché quello che lo scrittore spaccia per descrizione di realtà è solo un insieme di convinzioni, che sono indimostrabili, nella massima parte, e false per il rimanente. La narrazione è una forma di paranoia, la più alta ed evoluta se volete, che permette all’autore di codificare una serie di corrispondenze che vede solo lui. Il lettore è costretto a credere – tramite il rapporto sintassi, logica compositiva, storia – all’autore della storia e ai suoi personaggi. La famosa “sospensione di credulità” è appunto un avallo di una paranoia. La realtà e la letteratura sono due entità separate. «I segni caratteristici di tutte le cose, io sono qui per leggere» [III, 75]. Joyce parla dei signa rerum, i segni delle cose, delle impronte, che qualcuno deve interpretare: questo esclude la possibilità di conoscere la cosa in sé; del reale conosciamo solo i segni, le orme, il passaggio, non la intima essenza: si conosce negando la realtà, si conosce costruendo una riproduzione di un impronta negativa.
Nota: L’edizione che seguo in questa lettura annotata è J. Joyce, Ulisse, trad. M.Biondi, Nave di Teseo (2020). I numeri romani capitali indicano i capitoli, i numeri arabi la pagina di questa edizione. Qualora e in qualche citazione si usasse un’altra edizione verrà ovviamente segnalata.