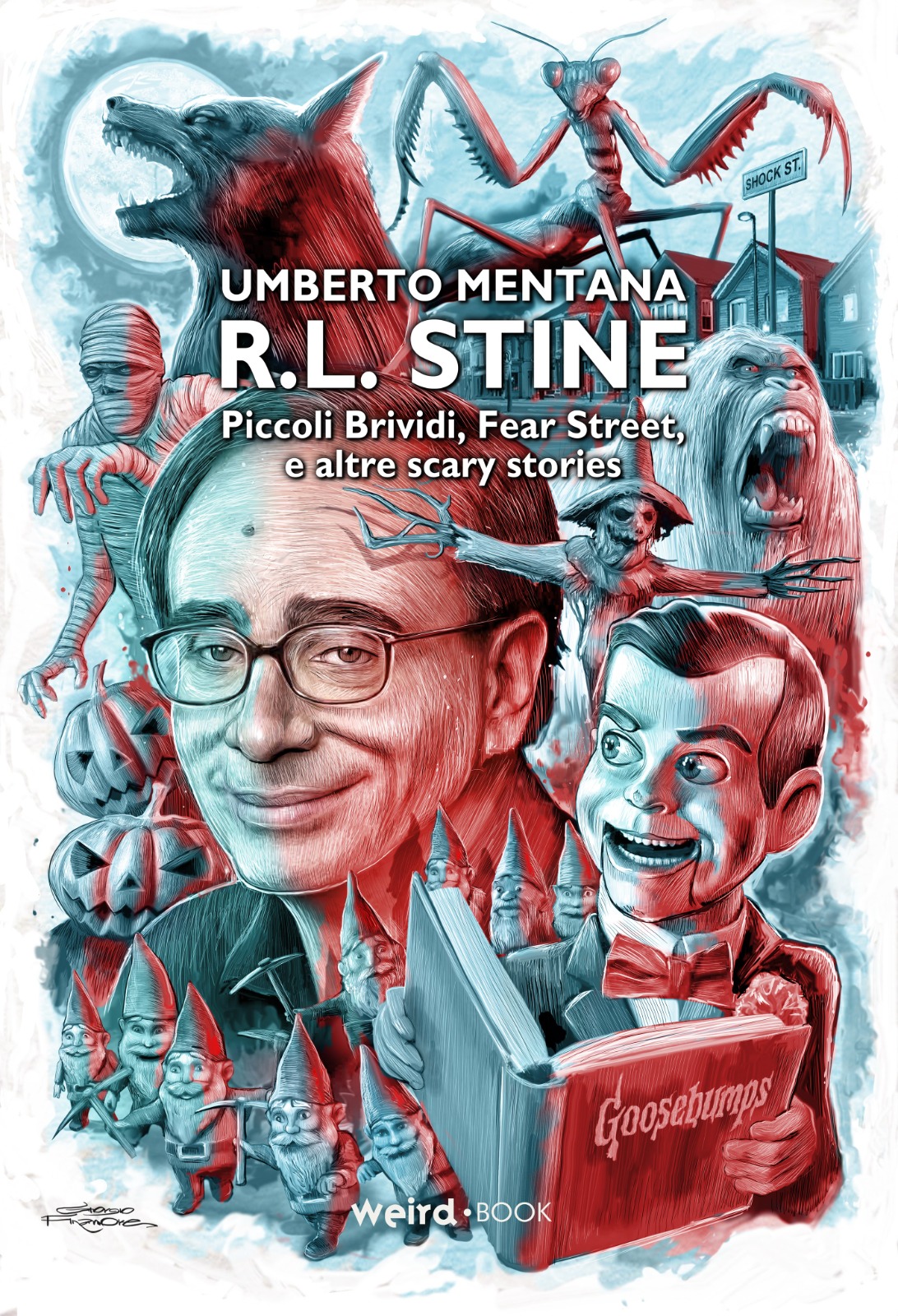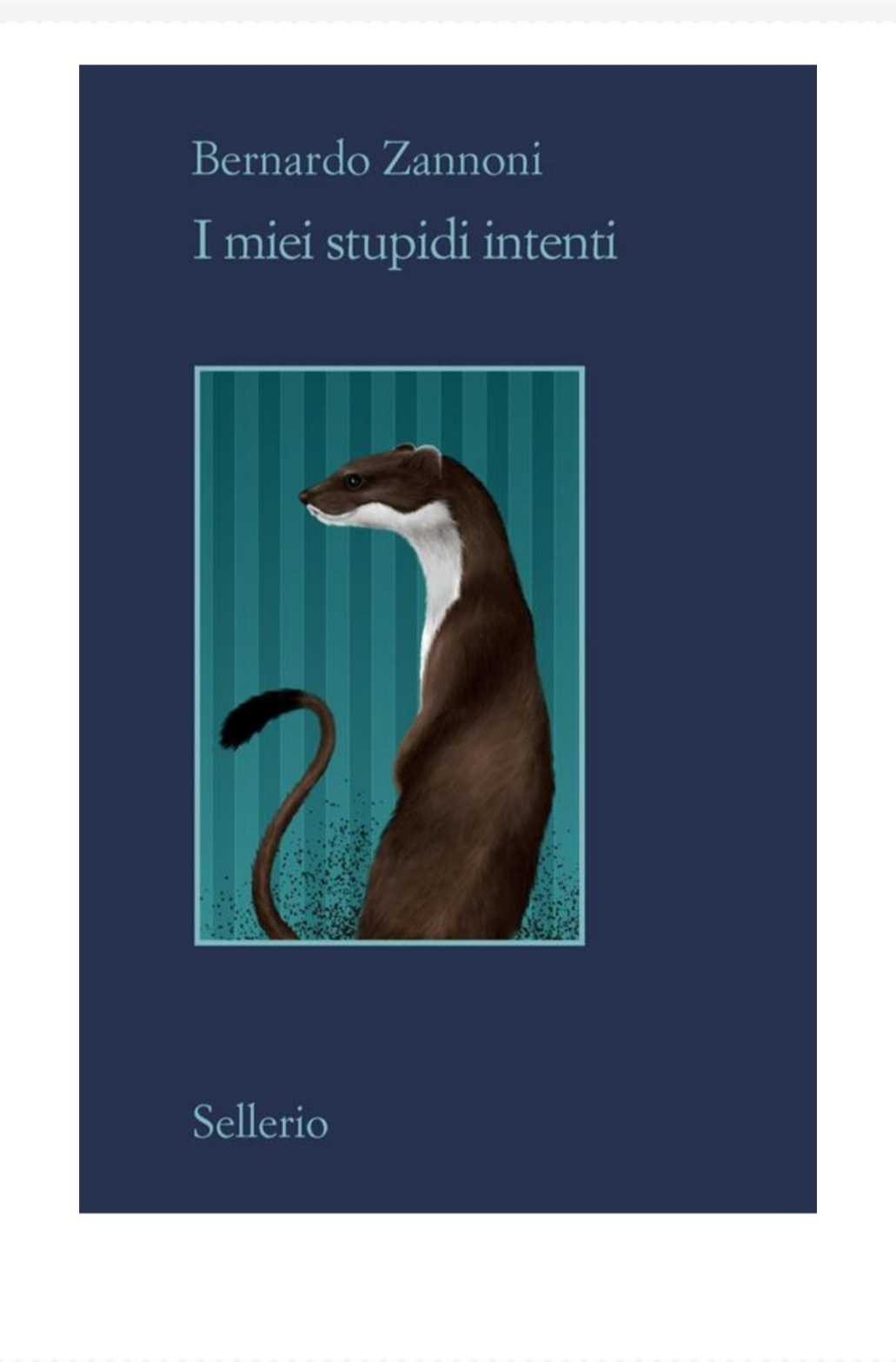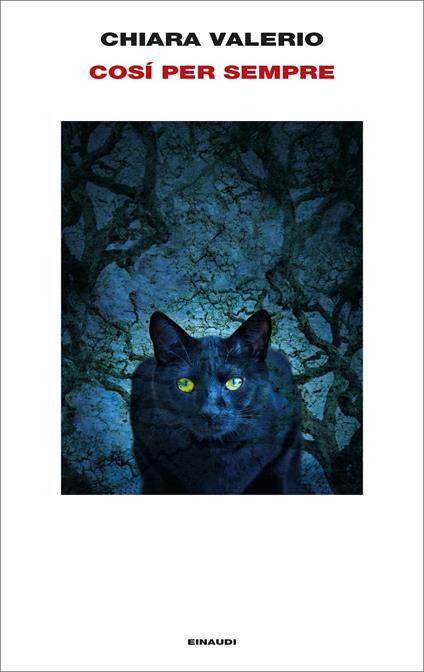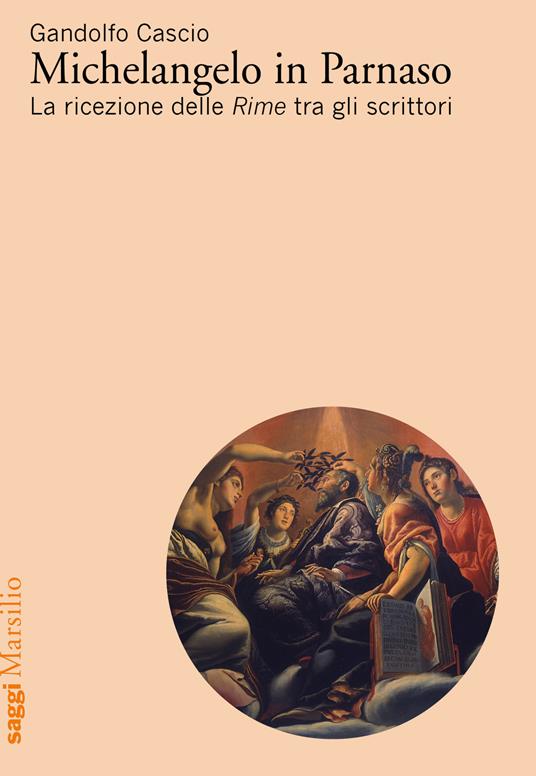di Annasara Bucci
Mio padre morì perché era un ladro. Rubò per tre volte nei campi di Zò, e alla quarta l’uomo lo prese. Gli sparò nella pancia, gli strappò la gallina di bocca e poi lo legò a un palo del recinto come avvertimento. Lasciava la sua compagna con sei cuccioli sulla testa, in pieno inverno, con la neve
Archy nasce faina nella tana dei suoi genitori in un rigido inverno di freddo e neve, e nascendo sa che dovrà sopravvivere da animale per tutta la vita. O quasi.
Una cosa è certa: la lotta per la sopravvivenza è l’energia che muove la vita di qualsiasi animale. Ed è per questo motivo che quando esseri animali abitano l’inchiostro sulla pagina, non sempre occorre fornire ulteriori spiegazioni. Non bisogna spiegare i motivi delle lotte dei fratellini di Archy per assicurarsi il cibo migliore, poiché chi più mangia più diventa robusto; non bisogna spiegare perché Otis, il più debole dei fratelli, corre il rischio di essere mangiato vivo quando la fame prende il sopravvento e le provviste non bastano a placarne la morsa; non bisogna chiedersi nemmeno perché la madre di Archy decide di venderlo a Solomon la volpe per una gallina e mezzo, dopo che un incidente lo ha reso zoppo, dunque inabile ad una vita da sano animale.
«È lui, Annette?», disse la volpe, indicandomi.
«Sì», rispose lei.
«Sembra sano».
«È zoppo. Non corre. A me non serve più».
La vecchia volpe rise.
«E a me sì?»
«Può lavorare. Sei vecchio, e non puoi trovare di meglio»
La vita di Archy subirà violenti strattoni di ferinità sin da subito, sin da quando ancora poco più che cucciolo, ancora poco abile alla vera vita da animale, si vedrà strappato dalla propria tana da chi lo ha generato, ed essere figlio inizia a non essere più considerato diritto acquisito se proprio la fame interviene a (ir)regolare i rapporti di filiazione. Nella tana di Solomon la volpe, Archy non verrà più nutrito per diritto, ma sarà messo a dura prova. E solo se lavorerà duramente acquisirà il diritto al nutrimento.
Per di più, Solomon è un padrone oscuro, violento, conosciuto in tutta la foresta come Solomon l’usuraio.
«Fai da mangiare e stai zitto, pelo di culo!»
Nessun animale della foresta che ha avuto l’ardire di fare affari con lui sfugge all’estinzione dei debiti, conti annotati accuratamente su tavole di legno con segni incomprensibili. Gli stessi segni che Archy nota su un libro che Solomon porta sempre tra le zampe, una cosa preziosissima, a giudicare dal ringhio e dal pelo dritto che il padrone mostra tutte le volte che qualcuno tenta di avvicinarvisi.
«Vuoi conoscere Dio, Archy?»
Il grande tesoro del suo padrone è un libro che riporta la parola di Dio e sarà proprio attorno all’importanza della parola e del segno grafico che ruoterà la mutazione del loro rapporto: da un subordine di servitù alla filiazione allievo- maestro. E come tutti i migliori maestri, non solo Solomon insegna all’allievo la lettura e la scrittura attraverso la parola di Dio, sciogliendo ogni suo dubbio, rispondendo ad ogni sua domanda, introducendo per lui i concetti di Tempo e Morte del tutto estranei al meccanismo del vivere animale, ma riconoscerà nell’allievo quel potenziale nascente che solo l’occhio di un maestro sa riconoscere.
«C’è dell’Amore qui, fra le parole. Non si legge, ma si sente […] Voglio che tu scriva di me, come sai fare, con Amore».
Dopo aver dotato l’allievo degli strumenti intellettuali necessari, gli chiederà di riscrivere il libro della sua vita da malfattore fatta di astuzie e inganni, ladrocini e omicidi sotto un’altra luce, quella di Dio, mutuando ogni gesto animale e disgraziato sotto la luce di un bene superiore.
Il tentativo di redenzione di un maestro disperato dalla consapevolezza della sua fine costa alla narrazione delle sue imprese la deformazione tutta umana di essere ammantata di un significato più puro, poco ferino, e per questo estraneo ad ogni logica animale. Infatti, quando Solomon muore, non spirerà come un qualsiasi animale preoccupato solo di vivere per vivere, ma con il terrore di un qualsiasi uomo attaccato alla vita per Sopra-viverla e lasciare una traccia del suo passaggio, con la disperata consapevolezza di lasciare non solo il proprio battito ma soprattutto il proprio posto nel mondo. Non passerà molto tempo prima che anche Archy soffrirà per questo eccesso di umanizzante razionalizzazione a scapito del suo istinto animale, proprio come il suo maestro.
Alla morte del Solomon, Archy lascia la tana e scopre da solo il bosco, e con esso tutta la potenza del suo essere animale. È con la presenza del luogo naturale e lo stanziare consapevole del corpo dentro l’elemento natìo ha inizio la vera conoscenza animale, la piena attività dei sensi: le fughe dai predatori, la lotta per il cibo, la foga dell’accoppiamento con Anja:
“Veloce percepii l’istinto salire dal basso, l’impulso di alzarmi e farla mia, lì davanti agli altri, senza paura né dubbi, senza cielo né terra, senza il mondo o Dio, perché non ero da altra parte se non da lei […] i nostri istinti si incastrarono alla perfezione, ballavano la stessa danza; il tempo si fece piccolo e il mondo si nascose, persi me stesso in lei, e lei altrettanto”.
Risvegliati i sensi da animale, dopo l’accoppiamento e con la nascita dei figli un periodo di magra costringe Archy e Anja alla fame; sarà per lui un atteggiamento tutto lecito (a conferma di un ritrovato mondo animale tutto istintuale e per questo totalmente amorale) il pensiero di uccidere uno dei figli per mangiarlo, proprio come quando, da cucciolo, i morsi della fame premono allo stomaco molto più del rimorso di uccidere il fratellino più debole. Sarà un istinto differente, quello materno di Anja, a salvare i suoi cuccioli dalle fauci di Archy e a preferire la morte o la fame piuttosto che vedere i suoi piccoli uccisi dal compagno, che comunque preferirà fagocitare una cucciolata di topi arrivati da poco in tana alla morte o allo scrupolo di coscienza.
Tutto il resto della vita di Archy è una sopravvivenza agli stenti, da vero animale. Alla fame, al freddo, agli attacchi dei predatori.
Sopravvive, salvato da un istrice, anche all’incendio appiccato nel bosco dal vecchio nemico del maestro Solomon, la lince Gilles, venuto a pretendere il suo tesoro, il libro della parola di Dio.
A quell’istrice insegnerà a leggere e a scrivere come il suo maestro aveva fatto con lui, ma guardandosi bene dall’introdurre i concetti di Tempo e Morte che avevano consumato e sporcato la sua vera vita da animale.
Non parlai mai di Dio, né della Morte. Decisi di salvare la sua vita dai grandi dilemmi che mi avevano afflitto, di lasciargli un’esistenza da animale. Dio sarebbe stato più contento, perché nella sua ignoranza già faceva quello per cui era stato creato.
Tra fame, stenti, freddo ed il desiderio di scrivere la propria storia, finisce la vita di Archy. Quel figlio che avrebbe voluto mangiare in preda alla fame, adesso adulto, lo ha sorpreso indifeso e ormai vecchio nella sua tana, e con violenza animale, come un cerchio che va a chiudersi per il lettore, lo uccide.
Sebbene la morte del protagonista concluda effettivamente il cerchio narrativo e chiuda il finale di intreccio, esso apre uno vero e proprio squarcio nella mente del lettore che costringe a ripercorrere il cerchio più e più volte, evitando qualsiasi taglio di lettura prospettica, soprattutto in senso morale. Si parta da un punto fermo: se è stato fatto l’errore di accostarsi a questa storia pensando di leggere una semplice favola di animali, completa di una sua morale definita, si rischia di perdere l’essenza dell’intero lavoro dello scrittore.
Sembra infatti, tra lo scorrere delle pagine di questo racconto etologico umanizzato o favola romanzata, che non vi sia alcuna voluta opposizione manichea tra Bene e Male o tra comportamento umano e comportamento animale, ma sltanto un esercizio di nuda realtà; esistono vicende che accadono agli animali per legge di sopravvivenza che essi affrontano secondo una logica prettamente animale, ed esistono i grandi concetti astratti appartenenti alla natura razionale umana (il Tempo, la Morte, Dio) che, nel momento in cui irrompono nella vita di un non-umano, ne modificano definitivamente il meccanismo di pensiero per mezzo della Ragione.
Da animale che dovrebbe vivere soltanto per assecondare l’istinto di sopravvivenza, Archy soffrirà per tutta la vita a causa della consapevolezza che un giorno la sua esistenza volgerà al tramonto, sofferenza derivante dal fatto compiuto di aver avuto accesso alla percezione del Tempo, e maledirà per tutta la vita un Dio creatore per le sventure capitategli.
Per Archy, questa avventura -che è insieme una sventura- parte dalla visione del suo maestro che ha voluto guardare oltre i meccanismi della propria esistenza, accostando la propria vita a dei significati sovra-istintuali, denaturandoli di fatto dalla percezione della vita naturale in senso animale (e quindi amorale) e non razionale secondo i meccanismi dell’umano agire.
È certo che Bernardo Zannoni sia riuscito a fare di questa storia una riflessione completa e complessa sui grandi temi dell’esistenza, incastonati in una disarmante semplicità di linguaggio. Assolutamente apprezzabile, per una penna giovanissima quale è quella di questo autore esordiente, il contrasto chiaroscurale tra una narrazione candida, limpida, tendente alla paratassi, e l’incedere per crescente profondità della vicenda narrata. Un’ottima prima prova narrativa che fa ben sperare per il futuro di questo scrittore.