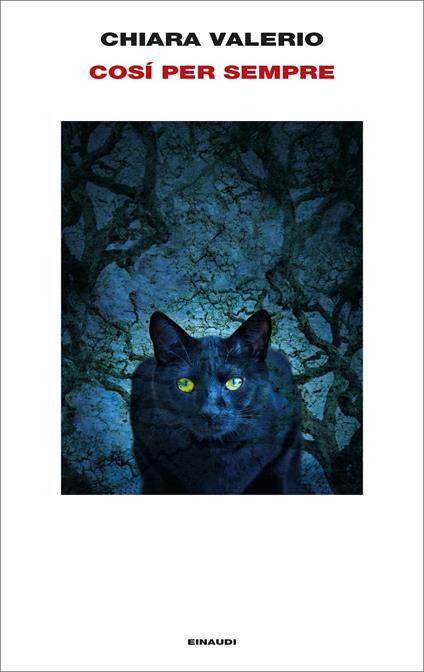Quando Jack Frusciante uscì dal gruppo alcuni di noi si aggiravano tra i banchi del liceo, altri erano già stati assorbiti dal flusso palpitante che riempie le aule universitarie. Tutti proiettati verso un futuro che sembrava aspettare solo i figli del benessere e della tivù commerciale, quella generazione X giudicata viziata tanto dai boomers quanto dai millennials. La generazione di mezzo, quella su cui i padri avevano investito capitali, riversato aspettative e, spesso, anche un certo desiderio di riscatto. I ragazzi degli anni Novanta, incastrati nel mezzo, tra un prima irripetibile, inarrivabile, e un dopo che si prospettava eccezionale. I ragazzi degli anni Novanta, gli anni del post comunismo e dell’Europa unita e a portata di Interrail, gli anni dei Segreti di Twin Peaks e del Pool di Mani Pulite, della fine della Prima Repubblica e del caos annunciato dalla Seconda. Eppure, il fascino che quegli anni esercitano ancora oggi è fortissimo e non solo in Italia. Già nel 2018 Nicholas Mathieu, con E i figli dopo di loro, ripercorre una storia della provincia francese negli anni Novanta: è proprio la provincia in quegli anni a ricoprire un ruolo fondamentale; ed è proprio lì, nella maggior parte dei casi, che in Italia si annida il germe della “narrazione cannibale”. Appena un momento prima c’era stato il Gruppo 13 di Lucarelli, Teodorani e compagnia che aveva raccontato una Bologna underground: costruendo storie che si ispiravano alla tradizione del noir all’italiana, quello di Scerbanenco e De Angelis e che non disdegnava atmosfere più cupe, con richiami al grottesco e al cyberpunk, il gruppo aveva dato una nuova connotazione a quel fantastico che era già stata la cifra di un altro milanese (integrato) come Buzzati. Ma all’ombra delle Due Torri non accadeva solo questo. Gli anni Novanta sono stati anni strani, anni in cui acquisivamo la consapevolezza che l’incanto si era spezzato. Allo stesso tempo, però sentivamo di dover chiudere finalmente i conti con la storia del Novecento, con il millennio e tutto il resto, gli anni della polvere sotto il tappeto, del muro di gomma a fare ancora da barriera a certi misteri di Stato ma anche a misteri apparentemente più piccoli. E allora ci accorgiamo che la narrazione maggiore – quella di Ustica ad esempio – trova punti di contatto con certe narrazioni della gente comune. Via Poma, Marco Dimitri, i fratelli Savi e la loro Uno bianca… Tutti questi eventi, nomi, date, si impastano e rimescolano fino a diventare una nuova vulgata. La gente comune è ora attratta morbosamente dai nuovi casi di cronaca nera che, altrettanto morbosamente, riempiono prime pagine e i palinsesti delle piattaforme streaming. Eppure, qualcuno aveva anticipato i tempi. Ad esempio, un gruppo di scrittori che a partire dai primi anni Novanta solleva il tappeto e ci sbatte in faccia lo sporco che nasconde. Sono i cosiddetti Cannibali: così li chiamò Daniele Brolli nell’antologia che curò nel 1996, Gioventù Cannibale.
Storie di quotidiana brutalità, popolate da mostri della porta accanto, banali, quasi anonimi rispetto ai loro più famosi predecessori. L’incubo metropolitano è fatto di figli, amici o semplici sconosciuti che diventano assassini per noia, per interesse, per puro sadismo o ferocia fine a sé stessa. Cronaca e finzione si mescolano, senza soluzione di continuità e le città finiscono per assomigliare sempre più alla Londra di Dylan Dog, investigatore di quell’incubo di carta e china, nato dalla fantasia di Tiziano Sclavi, snobbato dai fans di Tex Willer e Diabolik ma iconizzato dai loro figli.
Il movimento cannibale non era diverso dalla società che lo ha generato. Come un Leviatano, per qualche anno ha agitato il mare dell’editoria, per un fugace momento lo ha dominato, ma poi ha finito per fagocitare tutto, anche sé stesso. Eppure, la sua essenza, più che il semplice ricordo, è sopravvissuta al suo stesso nome. Ha dato l’imprinting a una nuova generazione di scrittori affascinata dall’estetica di questo movimento non compreso fino in fondo, quasi ghettizzato e l’ha riformulata. Ha guardato a quelle storie usando un filtro, ha addomesticato la ferocia con il riuscito espediente del gotico, del realismo magico di un tempo, con richiami al folklore e all’esoterismo.
A quasi trent’anni dalla celebre antologia, i Cannibali continuano a mordere attraverso nuove bocche e nuovi denti forse meno affamate di un tempo ma consapevoli di quanto quella narrazione della realtà sia stata profetica. Oggi che la cronaca ci restituisce verità ancora più agghiaccianti delle storie di lupi mannari bolognesi o certe ritualità fluo.
Cosa ne è stato di quella generazione di scrittori che, in blocco, sembrava destinata a macerare i vecchi arnesi della narrazione italiana? Si sono sparpagliati, un poco anche dispersi, ma il seme fu piantato. E oggi che Aldo Nove con Pulsar conferma la nuova vocazione autobiografica, ma non rinuncia a un linguaggio crudele; Isabella Santacroce con Magnificat amour accosta desideri e calvari (con Il Saggiatore a patrocinare il repêchage dei vecchi cannibali: si conta anche la riedizione di Woobinda) e, infine, Enrico Brizzi annuncia il sequel di Frusciante, si fiuta da lontano – forse – di nuovo l’odore acre di eccessi dimenticati.
Saranno accolti saggi (max 30000 battute) o articoli (max 15000 battute) su autori e temi legati ai Cannibali, con una attenzione particolare ai caratteri di un fenomeno ormai storicizzato; a quanto si è conservato della esperienza originaria e quanto è stato mutuato nelle scritture odierne e nei nuovi media, digitali e non.
Le proposte di contributo, con allegato abstract di max 150 parole e un breve profilo biografico, vanno inviate entro il 31 05 2024 al seguente indirizzo e-mail :
letterazero.nuovaserie@gmail.com