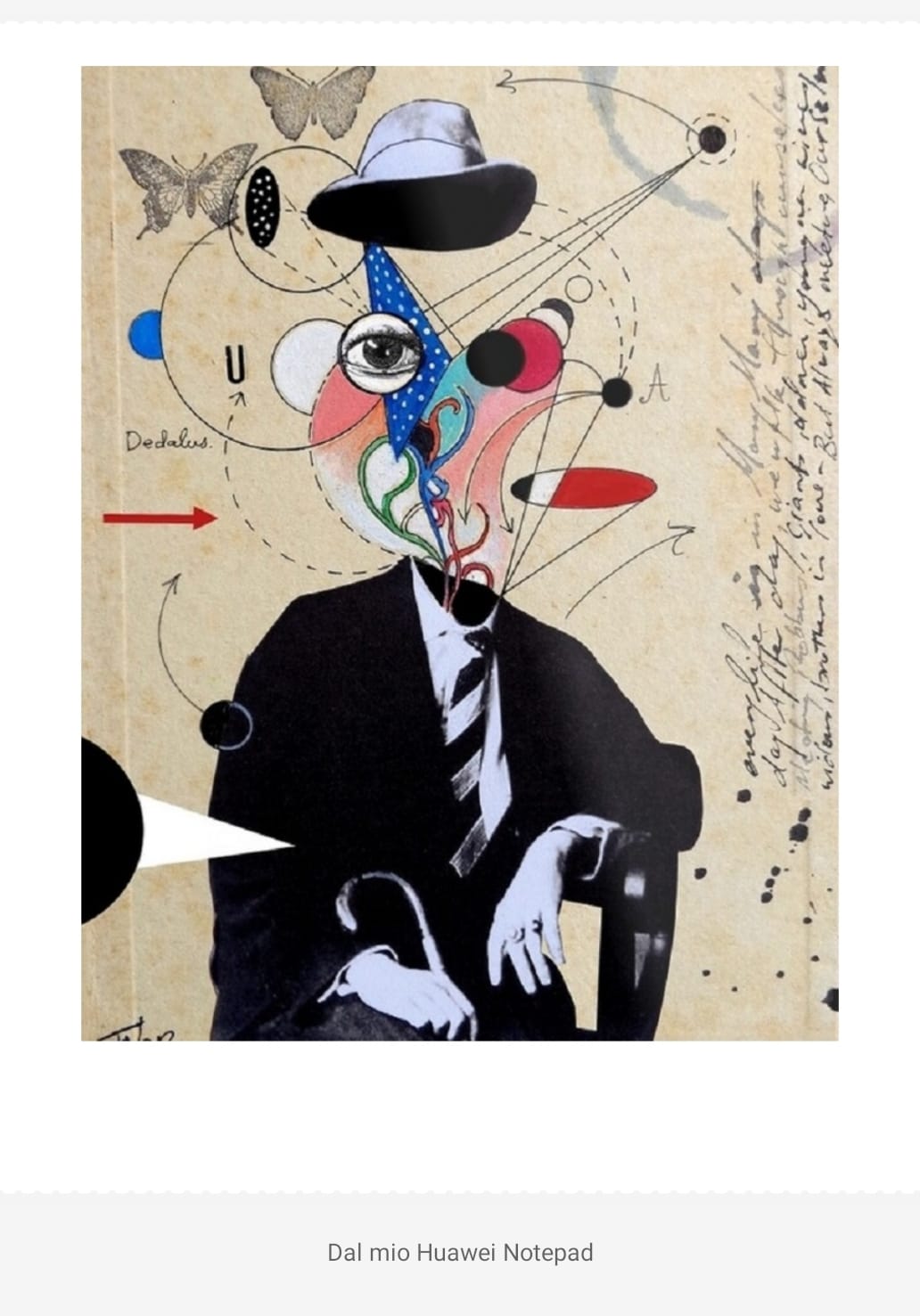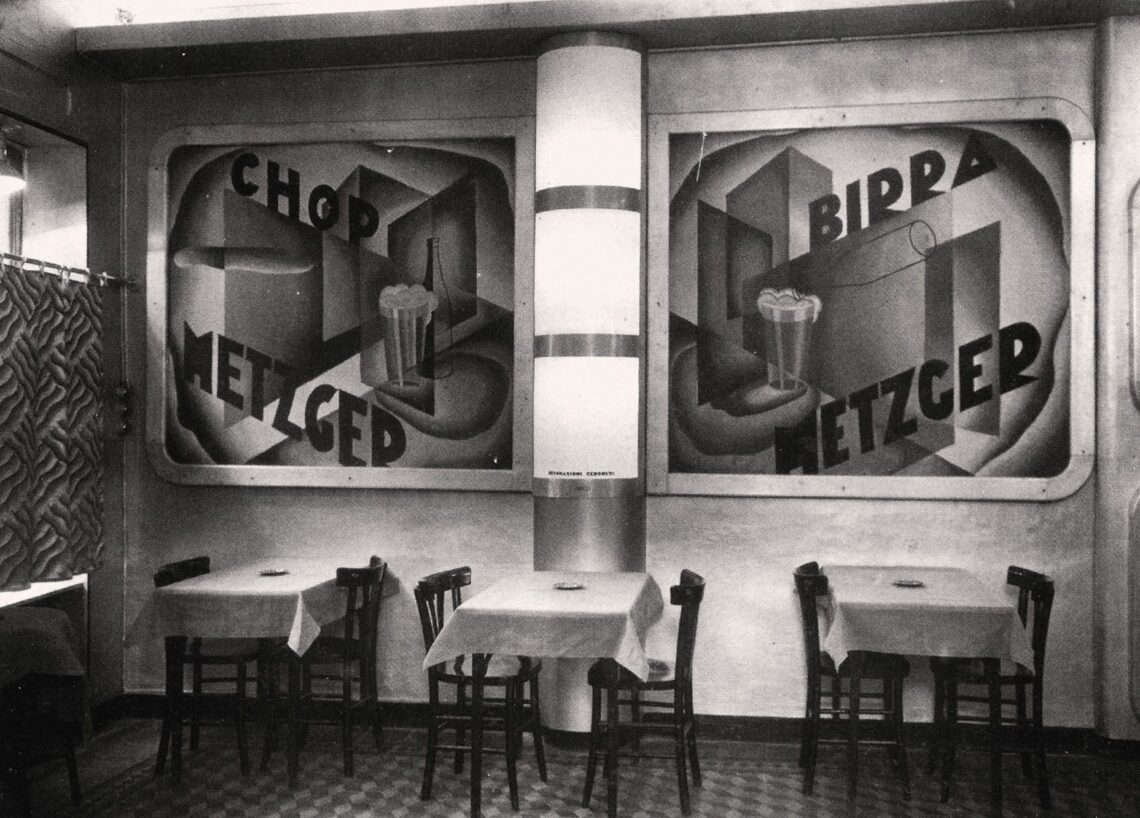di Annasara Bucci
Le vicende che nascono dalla narrazione dell’infanzia di Lila e Lenù non sono una tenera celebrazione della fanciullezza. Come nel caso di Elena Ferrante (o chi per lei), lo scrittore che ha deciso di raccontare la durezza delle cose non patisce mezzi termini nell’affidare alle vicende il compito di muovere la realtà, poi alla parola il compito di dipingerle: sono candidi occhi di bambine quelli che permettono al lettore di osservare la realtà narrata, ed il contrasto che tale occhio osservatore crea sullo sfondo della narrazione (fatta di cose terribili) non è una collisione straniante, bensì un collante che tiene uniti i passaggi tra l’infanzia e l’adolescenza insieme al lento rassegnarsi delle due piccole protagoniste all’inevitabile partecipazione alla rete della vita, al duro allenamento alle regole del gioco.
Il lettore le osserva muoversi di pari passo ai loro sguardi sulle cose, e così profondamente simili e diverse lasciano che anche il romanzo vesta i suoi primi abiti, come loro indossano i primi grembiuli di scuola. Le si osserva studiare, scambiarsi le bambole, assistere alle violenze domestiche e sociali del rione, persino subirle, qualche volta; le si osserva registrare gli eventi come piccole videocamere silenziose intente a riflettere e capire, superare le prime difficoltà, provando a sbrogliare -dapprima bambine e poi giovani donne- la matassa ingarbugliata di un mondo ai loro occhi ancora poco comprensibile.
Raffaella Cerullo ed Elena Greco sono due soggetti narrativi che nutrono e si lasciano nutrire dal motore di un romanzo sociale che affresca lo stato delle vicende di un’epoca in un preciso contesto territoriale, quello di un rione della Napoli degli anni ’50 in lenta riemersione dalla guerra.
Una Napoli presente attraverso le descrizioni dei luoghi delle protagoniste: affamata, sporca e desolata tra le strade del rione, brulicante e viva tra le strade principali del un grande ventre; ma, soprattutto, una Napoli presente attraverso la sua stessa essenza, la potenza della parola.
Quando parliamo della lingua del territorio napoletano dobbiamo fermarci a riflettere su un dato importante: questo dialetto, come molti dei nostri dialetti meridionali, sussiste come lingua-linguaggio: è una parlata ‘drammatica’, nel senso che l’intelligenza sostanziale della lingua si esprime non solo nella sfera della semantica ma soprattutto nella sfera del corpo, cioè del gesto. Affinchè la si comprenda interamente non solo bisogna conoscere tutto l’insieme dei suoi codici, bisogna più che altro essere capaci di avvertire i suoi sentimenti. È in ragione di ciò che quando si parla di ‘napoletanità’ ci si riferisce a tutto l’insieme dei sentimenti della cultura napoletana, di cui la lingua è parte integrata, assolutamente necessaria per comprendere i linguaggi in cui tale cultura si esprime. Stiamo parlando di una lingua di peculiare potenza espressiva in cui la comunicazione avviene per immagini, differenze di toni e accompagnamento di gesti ed espressioni: a pieno titolo, una lingua espressionista.
All’interno del romanzo, l’autrice sceglie di non utilizzare il dialetto in modo sistematico come lingua dei dialoghi: è un utilizzo silente, un impiego per singole espressioni, esclamazioni o utilizzo di soprannomi, molto spesso il dialetto è il mezzo espressivo dell’insulto volgare o reazioni sanguigne dei personaggi. Quando il dialetto interviene in modo più esteso durante il discorso è la scrittrice stessa a segnalarlo, riportando però il discorso in Italiano:
Andammo via mentre sentivo Lila che diceva indignata a Enzo, in dialetto strettissimo: «M’ha toccata, hai visto? A me, chillu strunz. Meno male che non c’era Rino. Se lo fa un’altra volta è morto». (Ferrante, 2018).
Come quasi sempre succede con i riadattamenti cinematografici, la storia del romanzo soffre qualche perdita dovuta al cambio dei linguaggi, alle scelte della regia o agli elementi della sceneggiatura, alla pluralità degli interventi necessari al passaggio tra narrazione del romanzo e narrazione destinata allo schermo. Nel caso della trasposizione cinematografica della quadrilogia, sin dalla prima serie è stata fatta una scelta di sceneggiatura coraggiosa e impegnativa, quella di trasporre gran parte dei dialoghi dall’italiano al dialetto. A beneficiarne è indubbiamente la potenza espressiva dell’intera vicenda narrata attraverso le voci degli attori che padroneggiano lingua, toni ed espressività in maniera pregevole e rispettosa degli elementi narrativi interni al romanzo.
Proprio qui, però, un problema: la presenza (inevitabile) sullo schermo dei sottotitoli che rendono i dialoghi in italiano corrente, come è successo anche con altre serie (si veda l’esempio di Gomorra o del più recente Strappare lungo i bordi).
Anche qui una riflessione: siamo un paese che possiede una particolare storia della lingua, i cui dialetti regionali erano a tutti gli effetti una pluralità di italiani parlati in ambito regionale da tutti gli strati della popolazione e a tuti i livelli della comunicazione, ufficialmente fino al momento dell’unità nazionale. La storia del nostro Italiano standard è recentissima ed i dialetti si mantengono ancora come parlate territoriali abbastanza caratterizzanti da non permetterne all’insieme dei parlanti del territorio italiano la piena comprensione.
In Lombardia abbiamo bisogno dei sottotitoli per comprendere il parlante del dialetto napoletano, in Friuli per comprendere il parlante del dialetto romano e viceversa, e così via lungo tutta la penisola.
Ora, il problema del sottotitolo osservato dal parlante che ignora un dialetto differente dal suo come fosse una lingua forestiera è che, pur traducendo in italiano corrente il contenuto del dialogo, non riuscirà a trasporre la totalità dei significati che quella lingua (soprattutto nel caso di un dialetto così espressivo come il napoletano) ha intenzione di veicolare. La perdita percettiva dell’ascoltatore è nelle sfumature di significati veicolate da toni, inflessioni, scelte di termini specifici, una perdita importante che riguarda il sentimento stesso dei contenuti che l’Italiano standard non riuscirà mai a tradurre o a colmare con la sua trasposizione.
Un risultato ancora peggiore si ottiene cercando di italianizzare per intero le espressioni dialettali, denaturando su più i livelli la correttezza dell’Italiano e sfibrando il dialetto nella sua peculiarità espressiva alla stessa maniera di Lenù, quando poco più che adolescente muove i suoi primi passi nella grammatica italiana soffrendo il passaggio dall’utilizzo sistematico del dialetto a quello dell’Italiano scolastico:
Mi resi subito conto che parlavo un italiano libresco che a volte sfiorava il ridicolo, specialmente quando, nel bel mezzo di un periodo fin troppo curato, mi mancava una parola e riempivo il vuoto italianizzando un vocabolo dialettale (Ferrante, cit.)
In un romanzo così intriso di napoletanità, viene spontaneo chiedersi quale romanzo leggano i connazionali del parlante napoletano che di napoletanità non è intriso, e quale il cittadino francese, inglese o spagnolo, (giacché il romanzo vanta una traduzione in circa 40 lingue) che conoscono la cultura napoletana soltanto come un mito tutto italiano. E noi, come avremmo letto la storia di Elena Ferrante se fosse nata in un contesto diverso da quello napoletano? L’avremmo letta come un romanzo di ottime potenzialità, indubbiamente. Ma orfano del suo terzo protagonista principale: orfano di una forma peculiare di sentimento della parola.